
1 Lacan
 Secondo
la psicoanalisi di Freud, come sappiamo, il soggetto è scisso in due principali
“sezioni”:
Secondo
la psicoanalisi di Freud, come sappiamo, il soggetto è scisso in due principali
“sezioni”:
- l’ IO che rappresenta la coscienza,
- l’ES che rappresenta il rimosso.
Lacan sviluppa questa teoria interpretando in generale il linguaggio umano come il sintomo della scissione interna al soggetto tra ciò che si dice di essere e di volere (frutto della pressione sociale) e ciò che di fatto si è e si desidera (effetto della combinazione della pulsione con la stessa pressione sociale).
.1.1 Lo stadio dello specchio
Il bambino prima dei 6 mesi, collocato davanti allo specchio, non si riconosce e non "sa" di esistere. Prima di riconoscersi nel riflesso dello specchio l’"io" non ha identità e non è distinto dal contesto.
L’io distinto si forma tra i 6 mesi e i 18, quando davanti allo specchio il bambino, muovendosi, riconosce la sua immagine riflessa.
L’io, tuttavia, è alienato perché il bambino non si identifica con se stesso ma con l’immagine che gli viene restituita dallo specchio.
 Il
bambino, se posto di fronte ad uno specchio, giubila per via dell’alienazione
di se stesso nello specchio. Il bambino non riesce a distinguere l’io immaginario
(cioè “se stesso”) dall’altro immaginario (colui che guarda allo
specchio). Il soggetto, distinto dall’io, è colui che guarda e si riconosce
solo alienandosi. Le immagini sono il luogo delle prime alienazioni.
Il
bambino, se posto di fronte ad uno specchio, giubila per via dell’alienazione
di se stesso nello specchio. Il bambino non riesce a distinguere l’io immaginario
(cioè “se stesso”) dall’altro immaginario (colui che guarda allo
specchio). Il soggetto, distinto dall’io, è colui che guarda e si riconosce
solo alienandosi. Le immagini sono il luogo delle prime alienazioni.
Il bambino costituisce, dunque, originariamente il suo  “Io”
come immaginario, l’alienazione di se stesso. Se ne sviluppa così un inconscio
dal lato del soggetto che rimane
separato dall’Io e dalle diverse “immagini” che si forma di se stesso.
“Io”
come immaginario, l’alienazione di se stesso. Se ne sviluppa così un inconscio
dal lato del soggetto che rimane
separato dall’Io e dalle diverse “immagini” che si forma di se stesso.
Dopo lo “stadio dello specchio” per Lacan è soprattutto il linguaggio che ci “aliena” in “Io” a questo punto non più “immaginari”, ma, come dice Lacan, “simbolici”. Il bambino si deve, dunque, alienare nei confronti di se stesso.
I “pazzi” (psicotici), in questa prospettiva, sarebbero coloro che vivono solamente all’interno di una dimensione immaginaria e non sanno distinguere le immagini dal reale.
L’identificazione può avvenire anche con i coetanei.
P.e.: Se un bambino si fa male giocando a pallone, l’altro bambino che lo guarda può piangere poiché si identifica con lui (fenomeni detti di transitivismo).
Lacan riconosce dunque una scissione originaria del soggetto umano in quanto tale.
Questa scissione è l’origine del desiderio inesaudibile che proviamo di qualcosa che ci manca. In effetti Lacan parla di “manque à etre”, di una vera e propria “mancanza ad essere”, simbolicamente rappresentata dalla castrazione.
.1.2 L'alienazione del linguaggio
La personalità si costituisce a partire da due registri
Ø IMMAGINARIO
Ø SIMBOLICO
IMMAGINARIO: è l’ordine della rappresentazione: ognuno costruisce la propria personalità in rapporto alle immagini che lo catturano e con cui si identifica, non si distinguendo sé dagli altri.
SIMBOLICO: è l’ordine del linguaggio: oltre che con l’immagine ci identifichiamo con il modo in cui parlano di noi: “io sono quello che gli altri dicono che io sia”.
CHI SONO IO?
Non possiamo sapere chi REALMENTE siamo perché non abbiamo mai una percezione diretta di noi stessi. Esiste una duplice alienazione, dovuta alla natura e alla civiltà, nell’immaginario e nel simbolico.
Ambiguità del linguaggio: per essere amati noi recitiamo una parte, ma l’amore che ci viene dato non è rivolto a noi ma al personaggio che recitiamo.
Es: quando ci laviamo i denti, perché i genitori ci hanno detto che "ci SI lava i denti" ovvero che "i bravi bambini si lavano i denti", ci comportiamo da bravo bambino.
Da un lato riusciamo così a conquistare l'amore che desideriamo, dall'altro lato però non conquistiamo questo amore per noi stessi, ma solo per il "personaggio" di cui recitiamo la parte: e non ci sentiamo amati in quanto noi stessi. Ma dovremmo chiederci: “chi” è esattamente quello che vorremmo che fosse amato?
Spesso problemi di insoddisfazione nei rapporti di coppia (metafore dell’originario legame col genitore di sesso opposto) derivano da questo “equivoco”.
L’io che enuncia è diverso dall’io enunciato;
Esempio:
![]() Per
me stesso io non sono professore
Per
me stesso io non sono professore
![]() Io
sono professore
Io
sono professore
Per voi io sono il loro professore
Quando vi dico “io sono il professore” chi parla non è colui che dice di essere (il soggetto che parla non è l’“io” della proposizione che enuncia)
Secondo Lacan tutto è prodotto del linguaggio ed è il linguaggio che ci aliena.
Tutte le cose per Lacan sono metafore del de-siderio
![]() DE
SIDERIO
DE
SIDERIO
![]() ALTROVE STARE SEDUTI
ALTROVE STARE SEDUTI
Tutti noi siano manchevoli di noi stessi. I desideri (di qualcosa di irreale, di virtuale) nascono per una sorta di falsa profondità (il senso) prodotta dal linguaggio, senza di cui questi non sarebbero mai nati, ma come animali saremmo spinti solo dai bisogni (di qualcosa di reale, di determinato)
In ogni domanda, dice Lacan, apparentemente rivolta a soddisfare un bisogno, per esempio in quella della pappa da parte di un bambino, si nasconde metaforicamente un desiderio dell’“amore della mamma”, che tuttavia non ha un oggetto determinato, è impossibile soddisfare, è un inganno della parola.
L’animale avrebbe solo il bisogno di mangiare: l’uomo, tradito dal suo stesso linguaggio, avverte il vuoto che si apre con angoscia dietro la parola “pappa”.
.1.3 La funzione del linguaggio nella costituzione dell'Io
La parola è ricerca del consenso (o dell'amore dell'Altro) à Se uno parla vuol dire che non è sicuro di qualcosa e cerca la conferma dal prossimo.
Quando sostengo con foga una determinata tesi lo faccio perché, in realtà, non ne sono sicuro e cerco una conferma dall'avversario (es. discussioni politiche)
L’IO è menzogna e de-negazione (‘Ma io…’)
Noi non ammettiamo mai che gli altri abbiano ragione perché dobbiamo difendere noi stessi (la nostra tesi che si identifica con il nostro IO) ® narcisismo.
Non ne va cioè solo di una qualsiasi opinione ma ho la curiosa impressione che ne vada sempre di me stesso, quando discuto, come se in causa ci fossi “io”. Questo perché io, in quanto alienato nel linguaggio, in un certo senso “io sono le mie opinioni”.
Se mi identifico troppo con la mia immagine (p.es. di insegnante) vado in crisi: non tollero nessuna opinione al di fuori della mia, ma in effetti così facendo difendo solo un'immagine “artificiale” di me stesso, di cui mi soddisfo solo in apparenza, e finisco per non sapere più nulla del mio desiderio, che tradisco.
.1.4 L'Io tra menzogna e verità
Cos’è la VERITA’ dell’INCONSCIO?
La verità non coincide con l’IMMAGINARIO che mi cattura la mente. Per questo nascono le nevrosi: perché io vedo le cose (deformate) attraverso il mio immaginario. Che quanto mi sembra vero, immaginariamente, non lo sia, me lo rivelano continuamente lapsus, sogni ecc., ossia il discorso dell'Altro, in me stesso, luogo del linguaggio e della verità.
LA VERITA’ è, tuttavia, solo un accordo stabilito tra me e il mio inconscio à costituisce perciò una REALTA’ SIMBOLICA, non ha a che fare con i "dati di fatto".
Per es. potrei "ammettere" che tutta la mia misoginia (odio per le donne) copre immaginariamente la "verità" dell'amore che desidero ricevere da loro, il quale a sua volta è tanto intenso perché mi è mancato quello della madre. Ora questa "scoperta", che potrebbe avvenire in un'analisi, non significa affatto che mia madre "realmente" non mi abbia amato, ma solo che ho interpretato così certi atti di mia madre e, in un secondo tempo, li ho rimossi sovrapponendovi la mia misoginia immaginaria. La "verità" rimossa coincide con quello che l'Altro mi dice simbolicamente nei miei lapsus e nei miei sogni, indipendentemente sia dalla costruzione immaginaria che le ho sovrapposto e che occupa la mia coscienza, sia dalla realtà effettiva dei fatti "storici" come sono avvenuti.
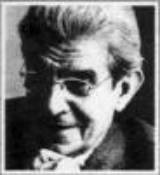 “Io ti amo” perché lo si dice? Forse se si
amasse veramente l’altro lo saprebbe e non ci sarebbe bisogno di dirlo. Parlare è sinonimo di insicurezza, di
desiderio di conferma e di risposta.
“Io ti amo” perché lo si dice? Forse se si
amasse veramente l’altro lo saprebbe e non ci sarebbe bisogno di dirlo. Parlare è sinonimo di insicurezza, di
desiderio di conferma e di risposta.
L’io genera imbrogli e menzogne, perché chiede il riconoscimento da parte dell’altro (ad esempio, in una discussione in cui si difende una tesi anche quando si ha torto, in realtà si difende l’io); più si usa la parola “io” e più si vuole nascondere qualcosa.
Il linguaggio (= cultura) crea un "modello" per ognuno di noi (p.es. se uno non sente parlare di amore in un certo modo non si innamora in quel modo): quindi il discorso determina l’io, che viene quindi ereditato di padre in figlio, accomunati dallo stesso linguaggio; i sentimenti e le azioni, quindi, non sono altro che l'effetto di modelli di discorso, ma il loro significato è sempre legato all'immaginario. Pertanto ciò che ci si "immagina" di realizzare seguendo il "discorso dell'Altro" porta a delusione.
Le persone sono trasparenti, rivelano una verità - anche quando non vogliono - col linguaggio del corpo (i sintomi). Basta saperlo leggere. L. arriva a dire, al riguardo, che la rimozione e il ritorno (o rivelazione) del rimosso coincidono: se per nascondere il mio innamoramento dico a tutti e anche a me stesso che una certa persona non mi piace è probabile che proprio questo mio dire (magari non richiesto, inopportuno, corredato da imbarazzo ecc.) riveli esattamente ciò che vorrebbe nascondere. Nell'atto della rimozione rivelo e rivelo proprio perché rimuovo.
La verità per un uomo non corrisponde mai alla realtà dei fatti, ma dipende da come si interpreta il passato alla luce del presente. Qui "interpretare" vale non "comprendere", ma "simbolizzare", "assegnare termini, metafore", "verbalizzare", del tutto indipendentemente dalla "coscienza" di quanto si simbolizza.
L’analista quindi non deve assecondare il paziente, perché renderebbe più forte l’io immaginario, o dare consigli, non deve neanche mentire per consolare perché la menzogna ha le gambe cortissime per l'altro che se ne accorge: mentre apparentemente si accomoda nell'immagine fornita dal medico, lo rifiuta come luogo della verità; l'analista deve solo riuscire a far risorgere il desiderio, anche se ciò provoca frustrazione dell'Io nel paziente che si sente soddisfatto (immaginariamente), pensa che l’analista non lo capisca, e continua a cercare in se stesso (cioè nelle sue fantasie di copertura o di difesa) la soluzione.
.1.5 La costituzione del Soggetto a partire dal linguaggio
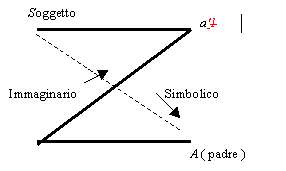
a
Nel soggetto si formano due immagini, quella visiva percepita (a) è l’altro immaginario (a') con cui ci si identifica e/o si compete (specchio).
Quando il soggetto si vede nello specchio esso compete con la sua immagine.
L’altro, il rivale, diventa un oggetto di identificazione, che risveglia in colui che si guarda nello specchio un desiderio "per interposta persona" (struttura di tipo immaginario).
Il nostro io si costruisce per imitazione dell'immagine allo specchio e quindi anche dei nostri simili.
Es : un bambino riceve uno schiaffo e anche un suo coetaneo che gli sta accanto si mette a piangere perché si identifica con il suo simile. Oppure i due piangono perché competono per lo stesso oggetto (per es. un giochino).
In un simile frangente può intervenire A (il padre) che permette al bambino di calmarsi dandogli un oggetto (o una parola, per es. una promessa) che diventi la metafora dell’oggetto ambito dall'altro bimbo.
Il padre per es. dà un palloncino a un bambino e a un altro bambino un trenino: questo atteggiamento può essere utile a far cessare il conflitto tra i due. Il bambino cessa la competizione perché ha avuto qualcosa che lo appaga per sostituzione. I due oggetti hanno in comune il significato che gli è stato dato: il simbolico in generale è il gioco della sostituzione. Il luogo topico di questo gioco è il linguaggio in cui le parole sostituiscono le cose che significano.
Che cos’è l’ALTRO con la A maiuscola? E' la fonte del discorso, il luogo della parola, qualcosa in noi o fuori di noi (il Padre) che ci interpella.
Mentre in “a” la rivalità è basata sulla forma, in “A” si tratta di linguaggio che è ciò che ci permette di superare la seduzione dell’immagine.
Es.
![]() Bisogno
Bisogno
![]() Per
Lacan c’è uno scarto tra la domanda della pappa e il soddisfacimento del
bisogno. La differenza tra la domanda della pappa e il bisogno è
il DESIDERIO. Ciò significa che l’uomo non può essere mai soddisfatto. Ma
questo gli permette di non saturare mai il proprio desiderio.
Per
Lacan c’è uno scarto tra la domanda della pappa e il soddisfacimento del
bisogno. La differenza tra la domanda della pappa e il bisogno è
il DESIDERIO. Ciò significa che l’uomo non può essere mai soddisfatto. Ma
questo gli permette di non saturare mai il proprio desiderio.
pappa
Ora questa differenza dipenda dal fatto che la domanda viene espressa con parole rispetto alle quali qualsiasi significato apparente (un x oggetto) si rivela insufficiente.
Linguaggio = è fatto da un insieme di segni che hanno tra loro un rapporto preciso, prima che avere un significato.
![]()
Strutturalismo
I rapporti non riguardano solo le parti del discorso, ma anche i fonemi interni alle parole.
Per es.: CANE ¹ CONO perché hanno diversi fonemi
Il simbolico è il linguaggio da questo punto di vista "strutturalistico", cioè concepito come "sistema" coerente con se stesso, prima che aderente a qualche realtà esterna, attraverso il "significato". Questa corrispondenza tra segno e significato è piuttosto immaginaria, come nell'esempio primordiale del termine "io".
Nei miei sogni se insistono certi fonemi (che, supponiamo, sono connessi con determinati desideri proibiti o con traumi) sviluppo immagini apparentemente incongrue (un cono al posto di un cane ecc.).
Es. "a me piace la mela". Si tratta, supponiamo, di una metafora "orale" del desiderio della madre. La parola "mela" è un significante che apparentemente sta per il frutto, ma in realtà viene usata, qui, per un altro significato, il desiderio della madre.
Freud a tale proposito direbbe che quando il bambino mangia la mela si trova nella fase orale e soddisfa così la sua libido, che quindi sembrerebbe trasmigrare "biologicamente" dai genitali alla bocca. Per Lacan invece è una trasmigrazione di linguaggio (la bocca diventa l’organo che soddisfa il bambino solo perché la mela è diventata una metafora del desiderio della madre che a sua volta è rivolto al fallo [F]).
“mi piace la mela” desiderio della madre IO
X =
![]()
![]()
![]()
desiderio della madre F F
Secondo questo schema l'Io si costituirebbe, simbolicamente, proprio come la metafora primordiale del desiderio della madre per il fallo del padre. In altri termini, il bambino, secondo Lacan, vorrebbe essere l'oggetto del desiderio della Madre, al posto del fallo del padre con il quale (fallo) finirebbe per identificarsi, sempre, però, attraverso metafore (per sfuggire alla censura). Come si può notare il desiderio freudiano dell'incesto viene qui interpretato come immaginario (non reale, biologico) e risolto simbolicamente (attraverso il ricorso al linguaggio)
 Il
Padre, in cambio dell'immaginaria soddisfazione del desiderio della Madre, ci
dà il linguaggio, il linguaggio che ci aliena attraverso le parole. La metafora
a cui ricorriamo nel discorso per indicare gli "oggetti" impossibili
del desiderio implica una rimozione di questi oggetti stessi. Quando questa
metafora, invece di esprimersi a parole, diventa sintomo, si cade nella
nevrosi. Se si restituisce la parola al desiderio allora si guarisce.
Il
Padre, in cambio dell'immaginaria soddisfazione del desiderio della Madre, ci
dà il linguaggio, il linguaggio che ci aliena attraverso le parole. La metafora
a cui ricorriamo nel discorso per indicare gli "oggetti" impossibili
del desiderio implica una rimozione di questi oggetti stessi. Quando questa
metafora, invece di esprimersi a parole, diventa sintomo, si cade nella
nevrosi. Se si restituisce la parola al desiderio allora si guarisce.
Noi siamo dei traduttori/traditori del linguaggio che parla dentro di noi (dall'Es, che Lacan, in francese, ridenomina ça) e se noi tacitiamo tale linguaggio dentro di noi tale rimozione prende le sembianze del sintomo (es. quando si diventa rossi perché non si riesce a dire qualcosa all'altro).
Noi dobbiamo parlare per soddisfare i nostri bisogni (Lacan parla di "parola piena").
Il soggetto, al di qua del discorso che fa su se stesso, è niente ma l’accorgersi di questo e che si parla di sé sempre solo per metafora è un passo per la salvezza dall’alienazione (siamo uomini perché siamo alieni a noi stessi!).
.1.6 La trama dei registri: reale, immaginario, simbolico
S
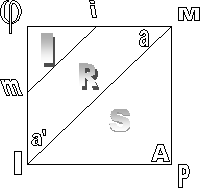 j rappresenta il fallo (significa il
significante mancante, l'origine delle metafore del soggetto): il bambino (S =
soggetto) percepisce che la madre non ce l'ha. Lui si percepisce come il fallo
mancante della madre e cerca di essere quello che manca alla madre.
j rappresenta il fallo (significa il
significante mancante, l'origine delle metafore del soggetto): il bambino (S =
soggetto) percepisce che la madre non ce l'ha. Lui si percepisce come il fallo
mancante della madre e cerca di essere quello che manca alla madre.
La ‘P’ rappresenta il padre che protegge la madre e non rende possibile al figlio arrivare all'esaudimento del desiderio.
La ‘S’ in basso rappresenta il campo del simbolico.
La ‘I’ è l’ideale dell’io.
La ‘i’ è la prima delle immagini che attirano la fantasia del soggetto (cioè la propria immagine allo specchio) fino ad arrivare all'immagine della madre (‘M’).
‘m’ è la fantasia dell’io che si specchia.
La ‘R’ significa il reale (gli eventi).
L ‘I’ è il campo del immaginario.
La ‘a’ e l’immagine dell’altro.]
1. Quale la funzione dello stadio dello specchio?
Lo stadio dello specchio illustra un’identificazione: nel momento in cui si percepisce un’immagine nel soggetto si produce una trasformazione. L’immagine riflessa del soggetto è la prima alienazione su cui si svilupperanno le altre: si è formata nel soggetto l’identità che esiste solo a livello immaginario.
2. Quale la fuznione dell'analisi nella prospettiva di Lacan
 La
funzione dell’analisi è di ascoltare, scandagliare il linguaggio usato dal
paziente in modo da individuare le parole piene, significative, o anche i
lapsus, le incertezze, gli errori di sintassi (essendo le une e gli altri
trasparenti sulla "verità" del soggetto), su cui porre l’accento
poiché nel paziente si faccia luce la verità (intesa come interpretazione
coerente attuale [in termini simbolici] dei fatti [= reale] che gli sono
capitati nel passato). L’analista non deve assolutamente rinforzare le
convinzioni dell’individuo, provocando una ricaduta del soggetto
nell’immaginario, oppure mostrare al paziente come deve comportarsi: così
facendo, infatti, l’analista assumerebbe su di sé, con troppo vigore, la figura immaginaria del padre (a
piccolo, mentre la sua funzione, negli schemi lacaniani, è espressa da A grande).
La
funzione dell’analisi è di ascoltare, scandagliare il linguaggio usato dal
paziente in modo da individuare le parole piene, significative, o anche i
lapsus, le incertezze, gli errori di sintassi (essendo le une e gli altri
trasparenti sulla "verità" del soggetto), su cui porre l’accento
poiché nel paziente si faccia luce la verità (intesa come interpretazione
coerente attuale [in termini simbolici] dei fatti [= reale] che gli sono
capitati nel passato). L’analista non deve assolutamente rinforzare le
convinzioni dell’individuo, provocando una ricaduta del soggetto
nell’immaginario, oppure mostrare al paziente come deve comportarsi: così
facendo, infatti, l’analista assumerebbe su di sé, con troppo vigore, la figura immaginaria del padre (a
piccolo, mentre la sua funzione, negli schemi lacaniani, è espressa da A grande).
3. Quale la funzione del linguaggio per l'uomo?
Il linguaggio, per dirla con terminologia freudiana, funge [all'incirca] da Super-io, è un retaggio della figura del padre ed implica la trasformazione dei bisogni in desideri. La sua funzione è di evocare, di appellarsi all'altro, non di descrivere oggetti, poiché nella parola si cerca un riconoscimento dall’interlocutore: in questo modo si stabilisce tra gli umani una fitta rete simbolica.
4. Confronta il concetto lacaniano di "verità" con quello che emerge da altre filosofie (per es. Nietzsche o positivismo logico)
5.
Quale la differenza principale, a tuo parere, tra la
concezione del soggetto che ha Freud e quella di Lacan?
S