Wittgenstein[1]

1.
Le radicali svolte teoriche che
all'inizio del Novecento avvenivano
all'interno delle varie scienze, non potevano non avere delle conseguenze sull'epistemologia, cioè
sulla teoria della scienza e, più in generale, sulla riflessione
filosofica.
1.1.
L'opera nella quale si trovano
riunite in maniera geniale tutte le principali questioni connesse ai mutamenti
del pensiero scientifico è il Tractatus
logico-philosophicus di Wittgenstein
(1921-22)[i].
1.1.1.
Nella prefazione egli chiarisce
qual è l'intento del libro:
1.1.1.1.
Il libro tratta i problemi filosofici e
mostra, credo, che la formulazione di questi problemi si fonda sul
fraintendimento della logica del nostro linguaggio. Tutto il senso
del libro si potrebbe riassumere nelle parole: quanto può dirsi, si può dir
chiaro; e su ciò di cui non si può parlare, si deve tacere…la verità dei
pensieri qui comunicati mi sembra intangibile e definitiva. Sono dunque
dell'avviso d'aver definitivamente risolto nell'essenziale i
problemi.
1.1.2.
Le tesi fondamentali del Tractatus
sono riassunte in sette proposizioni principali da cui derivano tutte le
altre:
1.1.2.1.
Il mondo è tutto ciò che accade;
1.1.2.2.
Ciò che accade, il fatto, è il
sussistere di stati di cose;
1.1.2.3.
L'immagine logica dei fatti è il
pensiero;
1.1.2.4.
Il pensiero è la proposizione
munita di senso;
1.1.2.5.
La proposizione è una funzione di
verità elle proposizioni elementari;
1.1.2.6.
Su ciò di cui non si può parlare,
si deve tacere.
Nomi Oggetti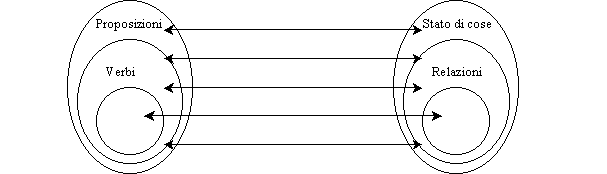
1.1.3.
L'opera inizia dunque con una affermazione
che riguarda l'essere del mondo: il mondo è tutto ciò che accade, quindi
il mondo è la totalità dei fatti, ovvero degli stati di cose [Sachverhalte],
cioè dei fatti che accadono indipendentemente l'uno dall'altro.
POSSIBILE
REALE
![]() COSE STATO DI COSE
COSE STATO DI COSE
![]()
![]()
![]() non sussiste
non sussiste
![]()
![]()
![]()
![]() sussiste
FATTO MONDO
sussiste
FATTO MONDO
1.1.3.1.
Il che sembra implicare che non
vi possa essere un nesso causale che giustifichi inferenze causali né
tantomeno la possibilità di derivare gli eventi futuri da quelli presenti.
1.3.1.1.1..
La fede nel
nesso causale - dice infatti Wittgenstein - è superstizione" [Tractatus,
5.1361]
1.1.3.1.1.1.
Da questo punto di vista, non
possono esserci, parlando propriamente, delle leggi naturali. Le leggi,
cioè le regolarità, appartengono solo al mondo della logica, mentre "fuori
della logica tutto è caso" (cf. ibidem, 6.3). Come già
sosteneva Hume, anche per Wittgenstein
1.1.3.1.1.1.1.
Non esiste una necessità in forza della
quale una cosa debba accadere perché un'altra è accaduta [6.37]
1.1.3.1.1.1.2.
Noi possiamo soltanto constatare
che vi sono delle cose che accadono. È uno dei presupposti empiristici presenti
nell'opera.
1.1.3.2.
Altra affermazione empiristica è l'identificazione
del pensiero col linguaggio,
1.3.1.1.2..
e l'estensione al pensiero della
stessa limitazione che vale per il linguaggio: non è pensabile né esprimibile
nulla che non sia un fatto del mondo.
1.3.1.2.2..
In altre parole, il linguaggio è
una sorta di raffigurazione proiettiva della realtà; non tanto nel senso
di immagine o copia bensì in quello di raffigurazione formale o logica del
fatto. Il linguaggio è la raffigurazione logica del mondo: da una parte
c'è il mondo, come totalità dei fatti; dall'altra c'è il linguaggio come
totalità di proposizioni o pensieri che significano i fatti stessi.
1.1.3.2.2.1.
Le proposizioni, a loro
volta, in quanto sono parole, segni, suoni ecc., sono fatti; però, a differenza
di altri eventi che accadono e stano muti, essi significano e
significano per l'appunto fatti.
1.1.3.2.2.1.1.
Da questo punto di vista, una
proposizione ha senso se
esprime la possibilità di un fatto: se cioè i suoi costituenti (segni o
parole) sono combinati insieme in una forma che è una delle forme possibili di
combinazione degli oggetti che costituiscono il fatto.
1.1.3.2.2.1.2.
Dal senso di una proposizione, va
distinta la sua verità, che si
ha quando la proposizione indica un fatto reale.
1.1.3.2.2.1.2.1.
Ad es. le
proposizioni "questa rosa è rossa" e "questa rosa non è
rossa" hanno entrambe senso perché sono entrambi possibili; ma una sola di
esse può essere vera.
1.1.3.2.2.2.
Oltre alle proposizioni
elementari, le quali esprimono le possibilità di fatti e non sono vere in
maniera necessaria ma solo quando i fatti le confermano (come nell'esempio
precedente è vero che la rosa è rossa quando vedo di fronte a me una rosa
rossa), vi sono anche altre proposizioni che esprimono la possibilità
generale dei fatti e che sono vere indipendentemente dai fatti stessi: sono
le tautologie.
1.1.3.2.2.2.1.
Ad es. la proposizione
"nevica" esprime la possibilità di un fatto ed è vera se il fatto
accade, quindi se in realtà nevica; e così pure la proposizione "non
nevica" esprime la possibilità di un fatto ed è vera se in realtà non
nevica. Ma la proposizione "nevica o non nevica" esprime tutte le
possibilità ed è vera indipendentemente dal tempo che fa o farà; il fatto che
nevichi o non nevichi non la conferma né la smentisce. Essa è dunque una
tautologia.
1.1.3.2.2.3.
Non basta. Prendiamo la
proposizione "questo scapolo è sposato". Essa non esprime più un
fatto ma una impossibilità. È quindi falsa indipendentemente da ogni fatto.
Essa è una contraddizione.
1.1.3.2.2.3.1.
La tautologia e la contraddizione
sono quindi rispettivamente necessariamente vera e necessariamente falsa
qualunque cosa accada. Il che equivale a dire che esse non sono
raffigurazioni della realtà, cioè non rappresentano alcuna situazione
possibile. Esse perciò non sono provviste di senso (a differenza delle
proposizioni elementari) ma non sono neppure dei non-sensi, bensì appartengono
all'ambito della logica simbolica vera e propria.
1.1.3.2.2.3.1.1.
Per Wittgenstein tutte le
proposizioni della logica sono delle tautologie nel senso che "non
dicono nulla", poiché non riguardano dei fatti ma solo delle operazioni
puramente linguistiche che stabiliscono ad es. equivalenze o non equivalenze di
significato tra diverse espressioni linguistiche. L'esperienza dunque non può
né confermare né contraddire le varie proposizioni logiche.
1.1.3.2.2.3.1.2.
Per Wittgenstein la logica e la matematica
costituiscono l'intero campo della necessità. Sol nella logica esistono
necessità e impossibilità, giacché i fatti, come si diceva prima, non hanno
necessità e non possono neppure averla le proposizioni che esprimono a loro
volta i fatti.
1.1.3.2.2.3.2.
Wittgenstein ha insomma
riproposto la distinzione di Hume tra le proposizioni significanti che
esprimono fatti possibili e le proposizioni non significanti ma vere che
sono le tautologie.
1.1.3.2.2.4.
Vi è però ancora un terzo tipo di
proposizioni che non sono né significanti né tautologiche e queste sono
chiamate da Wittgenstein i non-sensi.
1.1.3.2.2.4.1.
Orbene, per Wittgenstein la
maggior parte delle proposizioni filosofiche sono non-sensi. Infatti, visto che
per Wittgenstein noi non possiamo parlare del mondo nella sua totalità (poiché
non è un fatto), come invece pretende di fare la filosofia e la metafisica in
particolare, quando osiamo farlo, esprimiamo per Wittgenstein semplicemente
non-sensi.
1.1.3.2.2.4.1.1.
Le proposizioni significanti sono
infatti appannaggio delle scienze naturali e non consentono alcuna inferenza al
di là di ciò che mostrano o manifestano; d'altra parte le tautologie di cui si
occupa la logica non consentono di dire nulla sulla realtà e sul mondo.
1.1.3.2.2.4.2.
Il positivismo sostiene che ciò
di cui possiamo parlare è tutto ciò che conta nella vita. Invece Wittgenstein
crede appassionatamente che tutto ciò che conta nella vita umana è proprio
ciò di cui, paradossalmente, secondo il suo modo di vedere, dobbiamo tacere.
1.1.4.
Le teorie
del primo Wittgenstein costituiscono il principio di ispirazione della corrente
filosofica del positivismo
logico.
1.2.
Nella prefazione al Tractatus,
Wittgenstein aveva scritto di "avere nell'essenziale risolto
definitivamente i problemi". Di conseguenza Wittgenstein tacque. Per
diversi anni non si occupò più di filosofia. Ma nel 1929 egli ritornò a
Cambridge. Aveva concluso che i problemi filosofici non erano stati
definitivamente risolti. In particolare tre eventi
1.2.1.
la riflessione sulla
matematica,
1.2.2.
i colloqui con altri
pensatori e
1.2.3.
l'esperienza di maestro
elementare e la conseguente riflessione sul linguaggio infantile
1.3.
spinsero Wittgenstein ad assumere
una prospettiva teorica diversa nell'interpretazione del linguaggio.
1.3.1.
Per il cosiddetto secondo
Wittgenstein bisogna smettere di credere che il significato di un
termine consista in una realtà ad esso corrispondente, che ogni espressione
linguistica possieda un significato fisso, che tutte le proposizioni debbano
essere riducibili a proposizioni elementari e, in generale, che il linguaggio
coincida con le proposizioni "vere-false" che raffigurano la realtà.
1.3.2.
Secondo il Wittgenstein delle Ricerche
filosofiche, vi sono molteplici forme di
linguaggio e questa molteplicità non può neppure essere stabilita una volta per
tutte: nascono continuamente nuovi tipi di linguaggio, nuovi giochi
linguistici, mentre altri cadono in disuso.
1.3.2.1.
Wittgenstein sottolinea adesso la
natura pragmatica del linguaggio, e mostra come il significato sia
inscindibile dal contesto antropologico al cui interno l'attività
linguistica si costituisce. Esso è dunque funzione dell'uso, nel
senso che varia in relazione ad ogni variare del contesto d'uso, e viene in tal
modo a perdere ogni fissità. Il linguaggio è visto da Wittgenstein come un
insieme di giochi linguistici, che si costituiscono all'interno delle varie
forme di vita, dall'interno delle istituzioni e nell'ambito delle diverse
culture che si realizzano nel corso dello sviluppo storico delle società umane.
1.2.3.1.1..
Proprio per questo i giochi
linguistici sono sempre variabili, illimitati e non inquadrabili in uno
schema.
1.3.2.1.1.1.
Ciò implica pure che è illusorio
ogni tentativo di formulare una volta per tutte la logica del linguaggio,
intesa come qualcosa di fisso e di definitivo; anzi, più che di una illusione,
si tratta di una superstizione, il cui superamento rappresenta per
Wittgenstein il compito primario dell'attività filosofica.
1.3.2.1.1.1.1.
L’attività filosofica non
deve formulare teorie o fornire spiegazioni ma deve limitarsi a descrivere gli
usi effettivi del linguaggio.
1.3.2.1.1.1.1.1.
La filosofia non può in nessun
modo intaccare l'uso effettivo del linguaggio; può, in definitiva, soltanto descriverlo.
Non può nemmeno fondarlo [Wittgenstein, Ricerche
filosofiche]
1.3.2.1.1.1.1.1.1. In questo senso la filosofia può essere concepita anche come terapia del linguaggio.