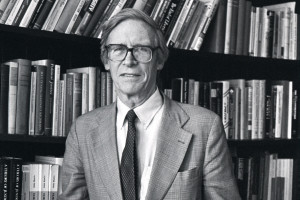Possiamo apprezzare il carattere rivoluzionario delle idee dei precursori della scienza economica.
Per la prima volta alcuni pensatori separano la ricerca individuale del bene da quella sociale. Non è più necessariamente vero che funzionino meglio e siano, quindi, più giuste e virtuose le società i cui membri sono, a loro volte, più giusti e virtuosi (come credevano i maggiori filosofi, Platone e Aristotele, ad esempio, e ritiene ancora un’istituzione come la Chiesa).
L’ipotesi, qui, ancora una volta, quella dell’eterogenesi dei fini.
Quello che il singolo persegue come fine o scopo (soggettivo, egoistico) diventa un mezzo per altri fini nella prospettiva di un’istanza superiore.
Nel caso dell’economia è la società (o il mercato) che opera con la sua “invisible hand”: sfruttando l’interesse egoistico dei singoli persegue il fine dell’incremento della ricchezza collettiva.
Consideriamo una relazione di compravendita: ciascuno dei due attori persegue il proprio interesse, ma, proprio in questo modo, finisce, involontariamente, per fare l’interesse dell’altro: il venditore proponendo i propri articoli al prezzo più basso possibile riesce a battere la concorrenza; il compratore riesce a fornirsi di beni spendendo il meno possibile. Il fine dell’uno è il mezzo che consente all’altro di conseguire il proprio fine. Nessuno dei due “ama” l’altro, cioè vuole immediatamente il bene dell’altro. Eppure, perseguendo il proprio fine, ciascuno persegue il fine dell’altro.
Ovviamente bisogna che ciascuno persegua il proprio fine rispettando le “regole del gioco”: non è consentito al venditore sbarazzarsi illegalmente della concorrenza (e operare così in regime di monopolio, cosa che gli consentirebbe di alzare il prezzo dei propri articoli), né al compratore di rubare la merce dell’altro.
Bisogna anche che ciascuno agisca in modo intelligente. Se, per esempio, un venditore volesse “gabbare” un cliente vendendogli un prodotto difettato o anche un prodotto sano, ma a un prezzo troppo alto, sul momento il venditore trarrebbe certamente un maggior utile dal suo comportamento, ma di lì a poco si spargerebbe la voce di quanto accaduto e il venditore, persa la propria reputazione, subirebbe un danno ben superiore al vantaggio momentaneamente conseguito.
Si può confrontare il caso della compravendita con quello del dono. Chi, per amore di un altro, vuole donargli qualcosa, è sempre a rischio di sbagliare, per ignoranza dei gusti dell’altro. La cosa migliore da fare, anche se poco elegante, sarebbe donare all’altro non un determinato bene, ma del denaro per mezzo del quale l’altro possa procurarsi quello che desidera.
Se generalizziamo questi esempi che cosa ne consegue? Paradossalmente una società in cui ciascuno persegue i propri interessi, a condizione che rispetti le leggi, produce maggiore ricchezza e felicità complessive di una società in cui ciascuno si preoccupasse più del bene degli altri che del proprio. Vige qui il principio, caro al pensiero liberale, secondo il quale “ciascuno è miglior giudice del proprio bene”. I liberali intendono che ciascuno sappia che cos’è meglio per se stesso, più del proprio padre, professore, medico, parroco, re ecc.. Coloro che credono di fare il bene dei propri figli, studenti, pazienti, fedeli, sudditi ecc., meglio di quanto costoro saprebbero fare per se stessi, sbagliano (agendo, come si dice, “paternalisticamente”).
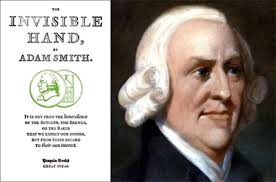 Sulla base di considerazione “rivoluzionarie” come queste, Adam Smith, filosofo morale, fonda la scienza economica col celebre Saggio sulla ricchezza delle Nazioni del 1776. La tesi di fondo, ottimistica, è che il sistema economico funzioni come una “mano invisibile” facendo coincidere l’interesse del singolo con quello della comunità.
Sulla base di considerazione “rivoluzionarie” come queste, Adam Smith, filosofo morale, fonda la scienza economica col celebre Saggio sulla ricchezza delle Nazioni del 1776. La tesi di fondo, ottimistica, è che il sistema economico funzioni come una “mano invisibile” facendo coincidere l’interesse del singolo con quello della comunità.
Questa intuizione può essere esemplificata anche considerando gli effetti della cosiddetta legge della domanda e dell’offerta in un mercato libero. Quanto più un bene viene ricercato (domanda) tanto più il suo prezzo cresce. Ma questo aumento favorisce l’aumento dell’offerta (dunque l’abbassamento del prezzo) in modo tale che alla fine, spontaneamente, il mercato – senza che nessuna mente lo pianifichi coscientemente – procura a prezzi ragionevoli tutto ciò di cui c’è bisogno socialmente.
Se, ad esempio, si diffondesse il bisogno di un nuovo farmaco, a causa dell’insorgere di un’epidemia, all’inizio i primi a metterlo sul mercato riuscirebbero a venderlo a prezzo molto alto, ma ben presto altri troverebbero conveniente l’affare e, immettendo quantità sempre crescenti di prodotto, contribuirebbero ad abbassarne il prezzo fino a un punto oltre il quale non sarebbe più conveniente produrlo (il punto in cui i costi di produzione eguagliano i ricavi delle vendite). Dunque, automaticamente, il sistema di mercato mette a disposizione il determinato prodotto al prezzo più basso possibile, consentito dai costi attuali di produzione.
Naturalmente tutto questo è possibile solo se non intervengono fattori perturbanti, come dazi doganali sul prodotto (che ne aumentano artificialmente il prezzo finale, avvantaggiando i produttori interni su quelli stranieri, anche se magari il prodotto interno è più scadente), forme di monopolio sulle materie prime necessarie a produrre il determinato bene (che avvantaggiano ingiustamente il fortunato monopolista), regolamenti corporativi che definiscono rigidamente i metodi da seguire nel produrre un determinato bene ecc.
 Nella prospettiva più radicale di Bernard de Mandeville e della sua Favola delle api (1705), il mercato riesce addirittura a “santificare i vizi umani”. Infatti, anche gli interessi più egoistici possono avere per effetto, per essere soddisfatti, la messa in moto di un meccanismo di mercato che finisce per diffondere il benessere generale.
Nella prospettiva più radicale di Bernard de Mandeville e della sua Favola delle api (1705), il mercato riesce addirittura a “santificare i vizi umani”. Infatti, anche gli interessi più egoistici possono avere per effetto, per essere soddisfatti, la messa in moto di un meccanismo di mercato che finisce per diffondere il benessere generale.
Attualizzando l’idea di Mandeville, che pensava soprattutto ai prodotti di lusso, si potrebbe pensare a mercati “immorali” come quelli dell’alcool o della droga. Questo genere di mercato consente a moltissime persone di trarre di che vivere, corrieri, traghettatori ecc. Anche al di fuori del circuito stretto del mercato “immorale” stesso la circolazione di ricchezza può favorire altri settori magari in crisi. I ricchi proventi di questi mercati, infatti, saranno spesi in auto, barche, case, alberghi ecc. arricchendo altre persone (i produttori di questi beni) che non sono direttamente “implicati” nel mercato “immorale”.
(Certo, a meno che non si parli, in simili casi, di “soldi sporchi”… Ma già i Romani sapevano che “pecunia non olet”!).
 Da quest’ordine di considerazioni sviluppate da filosofi morali che possono essere considerati precursori di una nuova disciplina, l’economia politica, trae spunto anche Jeremy Bentham, l’iniziatore del moderno utilitarismo filosofico (utilitarianism).
Da quest’ordine di considerazioni sviluppate da filosofi morali che possono essere considerati precursori di una nuova disciplina, l’economia politica, trae spunto anche Jeremy Bentham, l’iniziatore del moderno utilitarismo filosofico (utilitarianism).
Secondo Bentham (come secondo Epicuro, ma in modo più “scientifico”) il fine della vita è il piacere e l’etica si risolve in un calcolo del piacere. Il piacere è contraddistinto dalle seguenti proprietà: intensità e durata, prossimità e certezza (o probabilià), purezza, fecondità, estensione. Obiettivo della vita è massimizzare il piacere e minimizzare il dolore. In campo politico, deve Bentham si pone come radicale (cioè liberale democratico progressista), obiettivo è la “massima felicità per il maggior numero”, come già aveva teorizzato Cesare Beccaria.
L’ottimismo dei precursori dell’economia politica classica sulla capacità di autoregolazione del mercato cede tuttavia progressivamente il passo, presso gli stessi teorici dell’economia più avvertiti, alla comprensione dei limiti del modello teorico liberoscambista.
 Robert Malthus, nel suo celebre Saggio sulla popolazione (1798), che ispirerà anche la teoria di Darwin (relativamente alla lotta per la sopravvivenza nel mondo animale), osserva come, mentre una popolazione, di generazione in generazione, tende ad aumentare geometricamente, le risorse naturali su cui essa può contare, per quanto possano migliorare le tecniche agricole, tendono ad aumentare soltanto aritmeticamente. Ciò ha per effetto, per la legge della domanda e dell’offerta, la crescita dei prezzi dei prodotti agricoli e, in ultima analisi, il ritorno di situazioni di carestia. Il solo rimedio che Malthus, sacerdote anglicano, sa suggerire consiste nello scoraggiare i matrimoni (e, a maggior ragione, rapporti prematrimoniali) tra lavoratori.
Robert Malthus, nel suo celebre Saggio sulla popolazione (1798), che ispirerà anche la teoria di Darwin (relativamente alla lotta per la sopravvivenza nel mondo animale), osserva come, mentre una popolazione, di generazione in generazione, tende ad aumentare geometricamente, le risorse naturali su cui essa può contare, per quanto possano migliorare le tecniche agricole, tendono ad aumentare soltanto aritmeticamente. Ciò ha per effetto, per la legge della domanda e dell’offerta, la crescita dei prezzi dei prodotti agricoli e, in ultima analisi, il ritorno di situazioni di carestia. Il solo rimedio che Malthus, sacerdote anglicano, sa suggerire consiste nello scoraggiare i matrimoni (e, a maggior ragione, rapporti prematrimoniali) tra lavoratori.
Tuttavia la riflessione di Malthus, al di là delle sue proposte, mette in luce un dato rilevante: in un sistema di mercato reale, non immaginario, le risorse sono limitate e non illimitate: dunque l’aumento della domanda di un prodotto non comporta automaticamente, come sembrava credere Smith, l’aumento corrispondente dell’offerta del medesimo e, conseguentemente, l’abbassamento del suo prezzo al minimo compatibile con la copertura dei costi di produzione.
 Sviluppando quest’ordine di ragionamenti David Ricardo, nei suoi Principi di economia politica (1817), introduce il concetto di rendita fondiaria: nell’evoluzione del quadro economico descritto da Malthus coloro che detengono i mezzi di produzione (cioè i terreni più fertili), al crescere della domanda, data la rigidità dell’offerta (che non può strutturalmente aumentare oltre una certa misura), godono di profitti via via maggiori non giustificati dal loro lavoro o da innovazioni tecnologiche. Il loro maggior profitto può dunque venire chiamato giustamente rendita proprio perché non è determinato da investimenti produttivi.
Sviluppando quest’ordine di ragionamenti David Ricardo, nei suoi Principi di economia politica (1817), introduce il concetto di rendita fondiaria: nell’evoluzione del quadro economico descritto da Malthus coloro che detengono i mezzi di produzione (cioè i terreni più fertili), al crescere della domanda, data la rigidità dell’offerta (che non può strutturalmente aumentare oltre una certa misura), godono di profitti via via maggiori non giustificati dal loro lavoro o da innovazioni tecnologiche. Il loro maggior profitto può dunque venire chiamato giustamente rendita proprio perché non è determinato da investimenti produttivi.
Ricardo nota poi come nel rapporto tra datori di lavoro e lavoratori il profitto degli uni è inversamente proporzionale al salario degli altri. Il salario è, infatti, una componente dei costi di produzione. Perciò, a parità di prezzo del prodotto finito, quanto meno guadagna l’operaio, tanto più incamera il datore di lavoro.
A tutte queste distorsioni di un sistema di mercato ideale o astratto, determinate dalla scarsità delle risorse e dalla loro concentrazione in poche mani, i liberali non riescono a dare risposte conclusive.
 John Stuart Mill , allievo e seguace di Jeremy Bentham, nei suoi Principi di economia politica (1848) e nelle opere successive, prova a distinguere tra i meccanismi che presiedono alla produzione della ricchezza, da lasciare al libero gioco del mercato, e i meccanismi che presiedono alla redistribuzione della ricchezza in cui lo Stato e le associazioni operaie dovrebbero giocare un ruolo attivo (una sorta di distorsione del mercato a vantaggio dei meno abbienti compensativa della distorsione in senso contrario del mercato lasciato libero).
John Stuart Mill , allievo e seguace di Jeremy Bentham, nei suoi Principi di economia politica (1848) e nelle opere successive, prova a distinguere tra i meccanismi che presiedono alla produzione della ricchezza, da lasciare al libero gioco del mercato, e i meccanismi che presiedono alla redistribuzione della ricchezza in cui lo Stato e le associazioni operaie dovrebbero giocare un ruolo attivo (una sorta di distorsione del mercato a vantaggio dei meno abbienti compensativa della distorsione in senso contrario del mercato lasciato libero).
Possiamo fare poi un salto di più di secolo a John Rawls che nella sua A theory of Justice (1971) ritiene, come Mill, che il principio della difesa della libertà dell’individuo in ogni campo debba essere contemperato da un secondo principio: in un sistema economico liberale, pur sussistendo differenze di benessere tra individui, è necessario che coloro che godono di minor benessere ne godano comunque di più di quanto ne godrebbero in un sistema economico non liberale (p.e. socialista).
Rawls perviene a questa teoria attraverso un famoso esperimento mentale, quello del velo d’ignoranza: si immagini di “rinascere” in un sistema politico-economico a piacere, senza, tuttavia, sapere quale ruolo sociale giocheremo (non sappiamo, cioè, se saremo ricchi, poveri, lavoratori dipendenti, autonomi ecc.): come costruiremmo questo sistema politico-economico? Secondo Rawls dovrebbe essere un sistema liberale temperato dalla necessaria protezione dei più deboli.
economia, economia politica, etica, filosofia contemporanea, filosofia moderna, politica, storia della filosofia, storia della filosofia moderna, storia della scienza
Adam Smith, David Ricardo, economia, economia politica, economia politica classica, eterogenesi dei fini, invisible hand, John Rawls, John Stuart Mill, legge della domanda e dell'offerta, Malthus, malthusianesimo, Mandeville, mano invisibile, rendita fondiaria, Smith