Da qualche anno collaboro al progetto CamminaMenti, parte del più ampio progetto europeo Città Sane, del Comune di Udine.
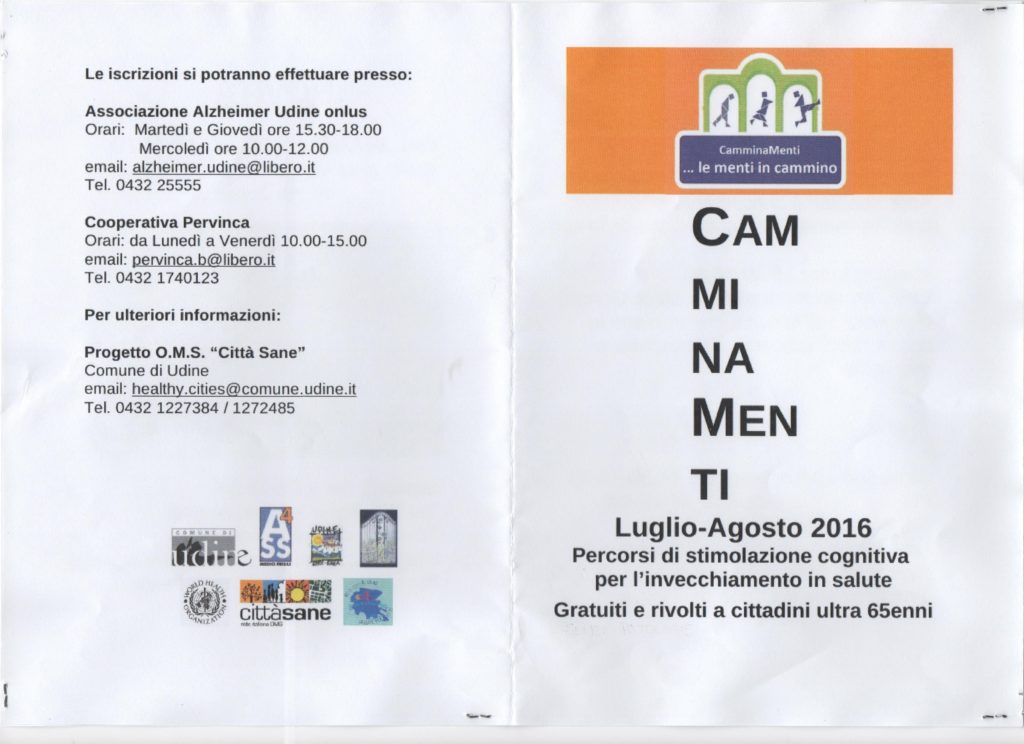
Nell’estate del 2015 ho effettuato un percorso di pratica filosofica (in quanto pensiero creativo) dedicato al tema del ritratto (eccone una sintesi).
Il tema di quest’anno (2016) è:
NOI E GLI ALTRI
Il percorso si è articolato in due momenti:
- il primo, più breve, sviluppatosi in quattro incontri, nel mese di marzo;
- il secondo, più lungo, articolatosi in otto incontri, tra luglio e agosto.
Entrambi sono stati realizzati presso la Cooperativa Sociale “Pervinca”
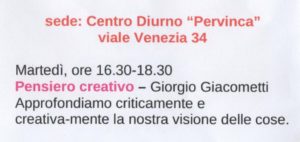
Segue un resoconto delle questioni principali emerse spontaneamente durante gli incontri, così come sono state sviluppate dal gruppo dei partecipanti sotto la guida del conduttore.
Il filo del discorso potrà sembrare talora spezzato da considerazioni apparentemente poco pertinenti o dall’emergere di argomenti apparentemente poco coerenti con quelli che precedono.
Ciò si deve alla natura propria di una pratica filosofica, in quanto attività libera di svolgersi secondo la domanda, il desiderio, il bisogno e l’interesse di chi vi partecipa, senza rigide forme di programmazione (quella che gli antichi chiamavano scholé, termine che ha dato origine al nostro “scuola”, ma che per gli antichi significava “ozio”, “tempo libero”, e veniva riferita, ad esempio da Platone, allo spirito che dovrebbe animare chi fa filosofia).
Incontri di marzo
Cerchi di migliorare te stesso, praticando lo yoga, esercitando forme di meditazione, attingendo una psicoterapia ecc.? Nessuno ti può garantire che gli altri, alla fine, non vengano a romperti le uova le paniere! Tua moglie, tuo marito, tuo figlio “disturbano” la tua “evoluzione spirituale”.
Rinunci alla TV, ti impegni a svegliarti ogni mattina alle 5 per fare jogging, cerchi di isolarti ogni 4 ore per praticare i tuoi esercizi… Ma i tuoi cari non te lo consentono, non rinunciano ai programmi televisivi preferiti, non ti permettono di andare a dormire abbastanza presto da permetterti di mantenere a lungo lo stile di vita che ti sei scelto, ti domandano qualcosa mentre stai cercando di concentrarti…
Spesso “il nostro prossimo” è fonte per noi di sofferenza, manda a carte quarantotto i nostri buoni propositi, suscita in noi sentimenti di stizza, rabbia, risentimento, delusione che frustrano il nostro tentativo di “crescere”.
Quante volte chi vuole davvero “evolvere” (per esempio intraprendere un cammino che lo porterà a diventare sacerdote, giudice, insegnante ecc.) deve abbandonare la sua abituale “compagnia” di amici, troppo sguaiati, scherzosi, usi a battute di cattivo gusto, a giochi puerili, senza avere ancora trovato una compagnia degna della sua evoluzione. Quanto spesso lo “coppie scoppiano” proprio perché uno dei due “cresce” troppo in fretta rispetto all’altro…
Ma chi sono davvero gli altri?
Facciamo alcuni esempi illustri di “conflitto” inatteso con altri noti:
- Ofelia amaramente delusa da Amleto

- Sordi e Gassman, nel film La grande guerra, “eroi improvvisati”, provocati dal comandante austriaco

- Achille, offeso da Agamennone, che fa letteralmente a pezzi Ettore dopo essersi rifiutato per mesi di combattere per gli Achei

- ma poi si commuove davanti a Priamo

Perché in tutti questi casi si registrano incomprensioni tra individui?
Incontro del 7 luglio 2016
Riprendiamo le nostre riflessioni, partendo da una domanda di fondo: “Che cosa pensiamo davvero dei nostri simili?”.
Per rispondere a questa domanda, traendo ispirazione dalla canzone Serial killer di Franco Battiato, immaginiamo di camminare, di notte, in un vicolo buio e di sentire alcuni passi alle nostre spalle.
Ne saremmo lieti? Esclameremmo: “Finalmente un altro essere umano, non sono solo/a”? O saremmo preda dell’angoscia?
Forse proveremmo paura, perché non sappiamo chi sia colui che ci sta seguendo. Se non tutti gli esseri umani sono malvagi, dobbiamo tuttavia mettere in conto che almeno alcuni lo siano. Ma quanti? L’1%, il 20%? Forse anche di più. Non abbiamo davvero una grande opinione dell’Uomo, se abbiamo tanta paura degli sconosciuti. Ci abbiamo pensato?
Certo, ci fidiamo degli altri quando agiscono alla luce del Sole, o quando vi sono ovunque videocamere di controllo (degna del Big Brother orwelliano) che ci rassicurano. Siamo più diffidenti, invece, quando sappiamo che i nostri simili potrebbero godere di impunità qualora commettessero delitti…
Ma perché siamo così diffidenti? Forse perché conosciamo noi stessi e sappiamo quanto siamo “pericolosi”. Per convincersene basta ripetere l’esperimento immaginario proposto da Platone nel II libro della Repubblica: se, indossando il magico “anello di Gige”, potessimo renderci invisibili e, quindi, impunibili, che cosa compiremmo? Siamo sicuri che saremmo così onesti? Magari non (tutti) ci abbandoneremmo a violenze di ogni genere, ma qualche piccola soddisfazione economica, forse, ce la concederemmo (svaligiando una banca, un negozio) o, magari, qualche piccola vendetta verso chi, a suo tempo, ci ha ferito… Non diciamo altro! Ognuno rifletta per sé!
Che cosa ci rende così (potenzialmente) malvagi? Il pensiero? La “mente” (da cui deriva il verbo “mentire”, quella facoltà che ci permette di “macchinare” trame….). Eppure la “consapevolezza” è anche ciò che ci permette di non cedere a paure irrazionali, così come di renderci conto di quello di cui dovremmo avere davvero paura.
Già, perché non è neppure così scontato che la paura degli sconosciuti sia giustificata. Forse essa deriva dagli incubi e dai fantasmi dell’infanzia, forse è indotta dalla cronaca nera… Eppure la cronaca nera riporta fatti reali, anche se a volte questi appaiono così simili alle tragedie greche. Forse in passato, per esempio dopo l’ultima guerra, si era così fiduciosi perché non si “sapevano” tante cose e se ne “sognavano” tante altre. Forse in passato sono sempre avvenute violenze, ad esempio tra le mura domestiche, ma non le si conoscevano. Forse, per riguadagnare fiducia nel prossimo, dovremmo semplicemente accettare di correre certi rischi, che una volta erano dati per scontati, magari perché non c’erano alternative.
Forse dovremmo osare incrociare occhi negli occhi chi non conosciamo e rivolgergli la parola: rompere il muro del buio e del silenzio sfidando l’altro alla comprensione e all’amore, come i “primitivi” che hanno inventato il saluto a mano aperta e la stretta di mano, per (di)mostrare la propria inermità.
Incontro del 14 luglio 2016
Ma, davvero, colui o colei di cui incontriamo lo sguardo ci rassicura? Pensiamo al caso dell’autostoppista. Immaginiamo, seguendo un celebre episodio della serie televisiva tedesca Der Kommissar, antesignana del più noto Ispettore Derrick, che una bella autostoppista riceva un passaggio su un camion.
Che cosa le permette di fidarsi del camionista? Lo sguardo di lui, il suo atteggiamento, la sua gestualità (tutto quello che possiamo rubricare come “non verbale”)? Sembrerebbe che un essere umano, sconosciuto, veduto, sia più rassicurante e “controllabile” di uno sconosciuto che si muove nell’ombra. Ma è proprio così? E se il Tizio recitasse una parte? Chi ha cattive intenzioni è spesso anche abile nell’arte dell’inganno. In generale, l’homo sapiens ha sviluppato molte arti, tra le quali quella dell’inganno.
E noi che cosa faremmo, nei panni dell’autostoppista? Forse, saliti a bordo, non ci basterebbe incrociare il nostro sguardo con quello del nostro “ospite”, ma cercheremmo di intavolare un discorso con lui, un discorso qualsiasi, sul tempo o, più verosimilmente, sulla nostra destinazione, non perché ci interessi veramente l’argomento (il linguaggio, qui, non assolverebbe una funzione informativa o descrittiva), ma solo per controllare che esista un canale di comunicazione (il linguaggio assolverebbe, cioè, una funzione “fàtica”. nella terminologia di Jackobson).
Quante volte, quando comunichiamo, non intendiamo veramente dire quello che diciamo, ma altro? Spesso quando sembra di informare l’altro di qualcosa (p.e. se dico a mio moglie: “Fa freddo!”) in effetti gli chiedo qualcosa (p.e. le chiedo implicitamente: “Perché non alzare la temperatura del condizionatore?”; funzione “conativa” del linguaggio)
Ma qual è lo scopo di queste comunicazioni, reciproche, indirette? Ci si domanda, implicitamente: “Sei una persona affidabile, hai principi morali?”. Più sottilmente, quello che vorremmo sapere dall’altro è se, in assenza di controlli, dello sguardo di altri o, magari, delle sempre più diffuse videocamere (succedanee tecnologiche di quel Dio onniveggente, “Grande Fratello” ante litteram, di cui si diceva: “Lui ti vede, Stalin no”), in lui operi almeno una “videocamera” interiore, uno “sguardo” divino interiorizzato (come la chiesa cristiana non è che un tempio greco interiorizzato, rovesciato, in cui il colonnato esterno si è fatto interno), insomma un “foro interno”, una “coscienza” morale. Il pericolo maggiore, infatti, quando si è soli con qualcuno (in auto, in ascensore ecc.), senza una “rete” di protezione di conoscenze (come avviene quando si flirta con qualche sconosciuto in una festa tra amici), viene da chi, mentre si vergognerebbe dei suoi delitti, se questi venissero alla luce del Sole, non si sente affatto in colpa a commetterli (il luogo comune attribuisce questo doppio volto soprattutto all'”uomo mediterraneo”, “italico”, erede dei Greci di cui sopra, spesso tentato p.e. da corruzione e concussione – vedi “tangentopoli” – perché “tiene famiglia”, ma talmente sensibile all'”apparenza” da arrivare talora al punto da “suicidarsi”, una volta che il suo delitto sia finito sulle prime pagine dei giornali)
Ma forse, in generale, l’essere umano, soprattutto il maschio, è contraddistinto da una potenziale aggressività di origine preistorica, che esplode a volte in certi luoghi (come l’Iraq, il Messico, la Somalia ecc.) dove è assente lo Stato (alla faccia dei teorici dell’anarchia), e che secoli di civilizzazione non hanno saputo addomesticare. Qualcosa in noi lo avverte (forse in noi stessi), lo sa. Per questo non ci fidiamo di nessuno, sia che si nasconda ai nostri occhi, sia che ne incrociamo lo sguardo?
Eppure non possiamo eludere il rischio, la sfida di incontri con sconosciuti, e non solo perché a volte abbiamo bisogno di loro, ma perché spesso l’ignoto ci seduce, ci attira non meno di quanto ci inquieti, come avviene nel corteggiamento: ci si innamora spesso di chi non ci è familiare (anche per ottime ragioni biologiche e antropologiche: le culture tendono per ovvi motivi a privilegiare l’esogamia all’endogamia…), di chi non è completamente affidabile (come potrebbe essere, viceversa, il nostro migliore amico), di chi è diverso, lontano, di chi ci inquieta, di chi, insomma, è contraddistinto da un ambiguo mistero…
Incontro del 19 luglio 2016
Ma perché, per riprendere la celebre differenziazione tra innamoramento e amore teorizzata da Francesco Alberoni, spesso la donna, almeno secondo il luogo comune, si innamora del “delinquente” e magari, da “crocerossina”, cerca di comprenderlo e redimerlo, e poi “sposa”, per amore, l’amico del cuore? Si direbbe che ci si innamori di chi è più diverso da noi, ma si ami, alla fine, chi ci è più simile. Ma è proprio così?
Forse colui che ci appare diverso risveglia “maieuticamente” in noi lati oscuri e segreti, affini ai suoi, che non sapevamo di avere e che risuonano nella nostra anima. Ci fa conoscere meglio noi stessi. Ci fa da specchio.
A volte, però, deformato o deformante. Una donna, bellissima, sconosciuta, suscita spesso in un uomo l’impressione di custodire segreti inauditi e ci ispira (in quanto “musa”) opere d’arte e d’ingegno straordinarie (poemi, dipinti ecc.). Spesso si sorride di questi casi (scherzando si dice di questa donna: “Basta che non parli”) e si suggerisce al “pover’uomo” di non lasciarsi ingannare dai suoi sentimenti, distinguendo, appunto, tra l’esperienza d’innamoramento e il vero amore. Ma l’innamoramento è solo la prima tappa dell’amore? Il suo termine è il matrimonio?
Le fantasie che èros suscita sono davvero vane? Oppure, come suggerisce Platone, l’innamoramento, anche, anzi soprattutto quando chi ne è preda (o “vi cade”, come direbbero gli Inglesi) ne rimane scornato, è un’insostituibile fonte di ispirazione? Forse senza Beatrice, che aveva il vantaggio di non essere mai stata veramente conosciuta da Dante (chissà? forse sarebbe stata una delusione!) e quello di essere… morta anzitempo!, Dante non avrebbe compiuto il suo viaggio verso il Paradiso… e noi non parleremmo la lingua italiana!
Anche quando iniziamo a conoscere l’altro, l’altro reale, non soltanto fantasticato (come nell’amore cosiddetto “platonico”), egli ci funge da specchio, può aiutarci a riconoscere i nostri pregi e i nostri difetti. O forse soltanto le nostre caratteristiche? Se li giudichiamo pregi e difetti significa che facciamo nostri i valori (morali) dell’altro (come appunto Dante che fu “stilnovisticamente” educato da Beatrice o chi si lascia guidare da un “maestro” o un “maieuta”). Ma, anche se non condividiamo la prospettiva dell’altro, i suoi giudizi ci possono servire come indicazioni. Ad esempio, un ragazzo che esce di casa in braghe corte, può entrare in conflitto con i suoi genitori che gli rimproverano il suo abbigliamento (sa, infatti, di piacere alla sua ragazza così agghindato); tuttavia, potrebbe fare tesoro delle osservazioni dei suoi qualora dovesse presentarsi a un colloquio di lavoro.
Tuttavia, meno l’altro ci somiglia, meno ci è sim-patico (cioè meno condivide le nostre passioni, in greco “pàthe“), più ci inquieta, ma a volte anche intriga. Ma le scelte (amorose, politiche, religiose) non contengono sempre un elemento di rischio? Giustamente, a volte vi “cadiamo” (come si cade nel “peccato”), ma non per questo non ne abbiamo paura. Perché? Perché, in fondo, non conosciamo l’altro. Ma non conosciamo neppure noi stessi!
Possiamo evocare al riguardo la famosissima canzone di Lucio Battisti, con testo di Mogol, Con il nastro rosa.
Inseguendo una libellula in un prato un giorno che avevo rotto col passato quando già credevo di esserci riuscito son caduto.
Vediamo come “lui” cerchi, qui, di sfuggire a un passato (di fragilità, debolezze ecc.) che, evidentemente, non giudicava buono, per finire poi col “ricadere” in qualcosa di sbagliato.
Si nota il lessico “para-religioso” (Battisti canta di una “caduta”, come appunto si cade nel peccato o nell’eresia) di questa, come di moltissime altre “canzonette” moderne di argomento amoroso. Esso proviene da una visione caratteristica dell’Occidente europeo, sviluppata dai tempi dei “poeti cortesi” e di Dante (ignota ad altre culture), forse ispirata da qualche eresia medioevale (quella dei càtari?), secondo la quale la “donna” è paragonabile a un angelo o addirittura a una divinità (pagana). Questa è almeno la celebre tesi del libro di Denis de Rougemont, L’amore e l’occidente.
Si può anche far risalire senza difficoltà questa visione “para-religiosa” dell’amore (tra i sessi), attraverso lo gnosticismo tardoantico (da cui probabilmente deriva il catarismo), allo stesso platonismo. Secondo Platone èros (l’amore come desiderio) può farci raggiungere il cielo, ma anche l’inferno, a seconda che sia orientato all’anima o al corpo dell’altro. Pensiamo non solo a Dante, ma anche a Petrarca con la sua Laura: capace di esaltarlo, ma anche di perderlo (a differenza della Vergine Maria a cui Petrarca dedica l’ultima canzone del suo Canzoniere).
Una frase sciocca un volgare doppio senso mi hanno allarmato non è come io la penso ma il sentimento era già un po' troppo denso e son restato
Da questi versi si vede come “lui” si accorga che “lei” non è come appariva al suo cuore. Forse è meno intelligente (“una frase sciocca”), più volgare (meno spirituale di quello che lui avrebbe gradito), la pensa diversamente da lui. Ma è troppo tardi. Nonostante l’ambiguità dell’altro, tipica dell’innamoramento, lui non può più ritirarsi.
Chissà, chissà chi sei chissà che sarai chissà che sarà di noi lo scopriremo solo vivendo
Ecco il passaggio chiave. Lui si getta a capofitto nell’avventura con lei, senza sapere chi veramente lei sia, chi diventerà e neppure che cosa saranno, loro due, insieme.
Ma ha senso “sposarsi” o, magari, anche solo “convivere” (promettendo, si presume, mari e monti) con chi si conosce così poco? Quando scopriamo, addirittura, di conoscere così poco anche noi stessi? Forse non era sciocca l’antica tradizione che faceva precedere al matrimonio un lungo fidanzamento. Erano vietati (come lo sono tuttora secondo la prospettiva cattolica) i cosiddetti “rapporti prematrimoniali” (forse perché “pericolosi” e non così utili a verificare l’effettiva “affinità elettiva” della coppia, in grado di garantire un rapporto di “lunga durata”); ma ci si poteva conoscere nei propri gusti, nel proprio stile di vita, e capire se si era davvero fatti l’uno per l’altra.
Lui, comunque, sa che “scoprirà” chi è lei e chi sono loro due insieme “solo vivendo”. Solo l’esperienza – sembra suggerire – può aiutarci a comprenderci. Ma se poi fosse troppo tardi?
Oggi molti “lanciano il cuore oltre l’ostacolo” senza giudizio (cence “sentiment”, come si dis par furlan). Il rischio, come abbiamo già osservato, fa parte del gioco. Ma l’incoscienza non è coraggio!
Comunque adesso ho un po' paura ora che quest'avventura sta diventando una storia vera spero tanto tu sia sincera!
Niente di strano che lui abbia paura e che non sia poi così sicuro che lei sia sincera: non solo perché – come abbiamo letto – a volte “lei” si lascia andare a “doppi sensi”, a “frasi sciocche”, ma forse anche perché nessuno può essere davvero pienamente “trasparente” su se stesso, senza l’altro (come dicemmo: a volte l’altro funge da specchio). La vita di coppia è sempre un po’ avventurosa, perché niente può essere dato per scontato.
Anche se volessimo, prima di sposarci, verificare a una a una le qualità dell’altro (come si tenta di fare oggi con certi siti di incontri, nei quali ci si presenta descrivendo meticolosamente i propri gusti, le proprie caratteristiche ecc.), ciò, ammesso che non sia di pessimo gusto (sembra di andare al supermercato e scegliere un prodotto….), sarebbe davvero possibile? Non siamo forse “infiniti”, come suggerivano Eraclito e Plotino? Dunque occorre sempre rischiare quanto basta e incrociare le dita (sperare).
Allora? Non si può fare proprio niente per garantire che si avrà successo? Forse non ci si può costringere ad amare e, meno ancora, a conservare il “fuoco” dell’innamoramento iniziale (fatto spesso di fantasie e illusioni sul conto proprio e dell’altro). Da questo punto di vista “promettere amore” (magari davanti a Dio o alla Legge) appare sempre un azzardo. Eppure si può forse trovare la via per “coltivare” l’amore: per favorirne, indirettamente, il prosperare, senza potercelo imporre. L’amore è forse come una piantina: non la si può far crescere “tirandola su” a viva forza (la si lacererebbe), ma se ne può coltivare il terreno… Certo, a condizione che abbiamo seminato in terra buona e non in terra arida, come ci ricorda la famosa parabola evangelica del seminatore.
Incontro del 26 luglio 2016
Riprendiamo dalla strofe della canzone di Mogol-Battisti Con il nastro rosa che recita:
Comunque adesso ho un po' paura ora che quest'avventura sta diventando una storia vera spero tanto tu sia sincera!
Di che cosa potrebbe avere paura “lui”? Che “lei” non sia come appariva, che non sia sincera, che lo tradisca ecc. Di solito le paure dell’uomo, in una relazione nascente, sono di questo tenore.
E le paure della donna? I troppi “femminicidi” di cui rende conto la cronaca nera suggeriscono che la donna possa temere dal suo uomo, a volte anche dopo una lunga frequentazione magari trasformatasi in una convivenza, molto peggio che forme di insincerità, tradimenti ecc.: veri e propri accessi di violenza, dettati da gelosia morbosa, senso del possesso, iracondia ecc. Si può mai dire di conoscere a fondo l’altro così da escludere che egli abbia un lato oscuro capace, quando meno ce lo aspettiamo, di emergere? O magari un lato oscuro, di cui abbiamo avuto sentore, ma i cui segnali fingiamo di ignorare proprio perché ne abbiamo paura.
In generale le nostre emozioni, come abbiamo riflettuto lo scorso anno, sono “tutto un programma”. Ciascuna di esse (paura, gelosia, ira ecc.) esprime una “visione delle cose”, a volte piuttosto complessa. La paura, ad esempio, spesso si combina con una “paura della propria paura”, per cui, come lo struzzo, si mette la testa sotto la sabbia per “non volerne sapere nulla” di quello che ci inquieta.
Ma la paura di un altro essere umano è davvero giustificata? Facendo un salto di più di duemila anni (rispetto alla canzone di Mogol-Battisti, erede, come dicemmo, di quasi un millennio di “lirica amorosa” d’Occidente) possiamo interrogare il poeta tragico greco Sofocle, vissuto nel V sec. a. C. In un celebre stasimo dell’Antigone Sofocle, forse per la prima volta nella storia dell’umanità, riflette sul “mistero” dell’uomo, animale straordinario, ma altrettanto inquietante (per la prima volta, cioè, l’uomo riflette su se stesso e si dipinge in un modo che suona piuttosto “moderno”…).
Molte meraviglie vi sono al mondo, nessuna meraviglia è pari all'uomo. Quando il vento del Sud soffia in tempesta, varca il mare bianco di schiuma e penetra fra i gorghi ribollenti; anno dopo anno rivolge, con l'aratro trainato dai cavalli, la più grande fra le divinità, la Terra infaticabile, immortale. E gli uccelli spensierati, gli animali selvatici, i pesci che popolano il mare, tutti li cattura, nelle insidie delle sue reti ritorte, l'uomo pieno d'ingegno; e con le sue arti doma le fiere selvagge che vivono sui monti e piega sotto il giogo il cavallo dalla folta criniera e il vigoroso toro montano. Ha appreso la parola e il pensiero veloce come il vento e l'impegno civile; ha imparato a mettersi al riparo dai morsi del gelo e dalle piogge sferzanti. Pieno di risorse, mai sprovvisto di fronte a ciò che lo attende, ha trovato rimedio a mali irrimediabili. Solo alla morte non può sfuggire. Padrone assoluto dei sottili segreti della tecnica, può fare il male quanto il bene. Se rispetta le leggi del suo paese e la giustizia degli dèi, come ha giurato, nella città sarà considerato grande; ma ne sarà cacciato se per arroganza lascerà che il male lo contamini. Spero che un simile individuo non si accosti al mio focolare, non condivida i miei pensieri.
Gli fa eco a distanza di millenni Giovanni Pico della Mirandola con la sua celebre orazione sulla Dignità dell’uomo (Firenze, XV sec.), manifesto dell’umanesimo moderno, nel quale pure si insiste sulla libertà dell’uomo di farsi simile a Dio o simile a un diavolo (o a una bestia selvaggia).
Ma questa libertà, che tanto ci piace , non è proprio quella che ci spaventa negli altri? Saremmo disposti a rinunciarvi, ingerendo una magica pillola capace di renderci assolutamente buoni e mansueti (ma privi della libertà di sbagliare, come gli angeli), a condizione che tutti gli altri la ingeriscano, in modo da “assicurarci” contro le cattive intenzioni del prossimo (sorta di vaccinazione collettiva a protezione dell’individuo)? Forse no.
Cionondimeno siamo disposti a farci circondare da videocamere in ogni angolo di strada…. Ritorna, infine, la questione dell’origine della “coscienza” come videocamera interna, che ci fa comportare bene anche quando nessun ci vede (e senza bisogno di ingerire pillole di sorta).
Nel romanzo di fantascienza Gli umanoidi di Jack Williamson, un classico del genere, il protagonista, a capo di un gruppo di “resistenti”, cerca in tutti i modi di sabotare il piano dei robot che controllano il mondo (gli “umanoidi” appunto) che vogliano “condizionare” quelli come lui per impedire loro di ribellarsi al nuovo ordine “robotico”. Alla fine del romanzo il protagonista soccombe, subisce il “condizionamento”. Nelle ultime pagine leggiamo come il mondo gli appare: pacificato, sereno, pieno di robot (che si rivelano) servizievoli e utili… Il lettore, “condizionato” a sua volta dal romanziere, si domanda se la battaglia contro il “condizionamento” valesse davvero la pena combatterla…
Ma perché abbiamo tutta questa paura degli altri? Forse perché abbiamo paura anche di noi stessi, del nostro stesso lato oscuro. Come si manifesta? Secondo alcuni, ad esempio, le semplici “vertigini” che proviamo davanti a uno strampiombo sarebbero un indizio del fatto che temiamo quella “parte di noi” che vorrebbe gettarsi nel vuoto. Siamo o non siamo attratti dal nulla, dalla morte? Se non lo fossimo, non si comprederebbe la segreta seduzione che esercitano su di noi gli sport estremi e i film appartenenti al genere horror. Sigmund Freud pensava che fossimo dominati, oltre che dall’istinto sessuale, anche da una “pulsione di morte”…
Forse perché conosciamo questo nostro lato oscuro temiamo quello degli altri? Possiamo “sperimentare” la morte, di cui siamo curiosi, prima sulla pelle degli altri che sulla nostra, per il brivido che questo comporta. Così sembrano fare coloro che “si immolano” per la jihad facendo stragi di propri simili (ogni giorno la cronaca riporta notizie di questo tenore) o, semplicemente, sono affetti da turbe psichiche che li inducono, per imitazione, a tali comportamenti, senza che la società moderna sia riuscita a intercettare per tempo il loro disagio.
A volte registriamo con preoccupazione l’inclinazione dei più giovani verso videogiochi “sparatutto” o per giochi di gruppo che hanno per tema la guerra o la morte. Come dovremmo comportarci? Vietare questi comportamenti sarebbe come negare la radice da cui promanano. In una prospettiva cristiana l’inclinazione alla violenza, che scaturisce dall’odio o dall’invidia, sarebbe segno del “peccato originale”. Un celebre passo di S. Agostino (Confessioni, 7, 11) lo riscontra perfino nei poppanti!
Dunque l’innocenza dei bambini risiede nella fragilità delle membra, non dell’anima. Io ho visto e considerato a lungo un piccino in preda alla gelosia: non parlava ancora e già guardava livido, torvo, il suo compagno di latte. È cosa nota, e le madri e le nutrici pretendono di saper eliminare queste pecche con non so quali rimedi; ma non si può ritenere innocente chi innanzi al fluire ubertoso e abbondante del latte dal fonte materno non tollera di condividerlo con altri, che pure ha tanto bisogno di soccorso e che solo con quell’alimento si mantiene in vita. Ciò nonostante si tollerano con indulgenza questi atti, non perché siano inconsistenti o da poco, ma perché destinati a sparire col crescere degli anni. Lo prova il fatto che gli stessi atti, sorpresi in una persona più attempata, non si possono più tollerare con indifferenza.
In una prospettiva più laica e moderna, come quella di Nietzsche o di Freud, il nostro “lato oscuro” esprimerebbe una naturale “volontà di potenza” da non giudicare, ma da comprendere. In entrambe le versioni si tratterebbe, comunque, di qualcosa del quale non ci possiamo semplicemente spogliare o che non possiamo “liquidare” come se non esistesse. “Se lo conosci, lo eviti”, come si suol dire.
Per tacere del fatto che, secondo alcuni, a volte il “male” non viene per nuocere, ma torna in conto di bene. Quando? Quando, p.e., il fine giustifica i mezzi (Machiavelli). Si gioca qui la complessa partita del rapporto tra due etiche (teorizzate dal sociologo tedesco Max Weber agli inizi del Novecento), l’etica dei principi, in base alla quale bisognerebbe sempre fare il bene (o quello che si ritiene tale), e l’etica della responsabilità, in base alla quale a volte ci si può assumere la responsabilità di fare il male per conseguire (quello che si crede) un bene superiore. Ma proprio così?
È giusto autorizzare interruzioni di gravidanza per combattere gli aborti clandestini, praticare la vivisezione in animali per studiare nuovi farmaci, torturare presunti terroristi per trarne preziose informazioni in grado di salvare la vita di persone innocenti, legalizzare le cosiddette droghe leggere per combatterne lo spaccio, sacrificare embrioni umani sull’altare della ricerca biomedica al fine di prevenire le malattie genetiche, lasciar morire chi soffre e chiede di morire per diminuirgli la sofferenza…? Ma tutto questo ci allontana dal nostro tema…
Incontro del 2 agosto 2016
Torniamo alla “paura” che i partner di una relazione di coppia provano… Che cosa possono temere? Che l’altro non sia come appare, che possa tradire…
Sempre di nuovo ci si scontra con l’abisso della libertà , che ci seduce nell’altro, alla quale neppure noi vorremmo rinunciare, ma che ci inquieta perché non garantisce affatto il futuro di una relazione.
Nessuno di noi vorrebbe rinunciare ad essere libero…
Ma siamo davvero liberi? I nostri desideri sono davvero nostri o sono piuttosto desideri parassiti, posticci. Se ha ragione lo psicoanalista Jacques Lacan, il “mio desiderio” sarebbe sempre solo il “desiderio del desiderio dell’altro” (di mio padre, di mia moglie ecc.). Non avremmo desideri davvero nostri (e non saremmo, quindi, liberi di esaudirli).
Forse, allora, è sufficiente esaudire i desideri, da chiunque provengano, che ci rendono felici, per dirci liberi? La vera libertà consisterebbe, allora, non nell’assenza di condizionamenti, ma nell’essere condizionati da qualcosa che ci permette di conseguire il maggior grado possibile di felicità. Sotto questo profilo, ad esempio, appaiono giustificati i necessari “condizionamenti” (ad esempio “religiosi”) di cui è intessuta una relazione educativa tra genitori e figli…
In generale, ogni “valore” o “principio”, come quello della libertà, ha un prezzo. Nel caso della libertà, ad esempio, il prezzo da pagare è una riduzione della “sicurezza”.
La filosofia ci fa riflettere sul fatto che spesso i “principi” più sacri, a cui non saremmo disposti a rinunciare (e giustamente), sono in contraddizione con principi altrettanto sacri, con i quali dobbiamo mediare. Ecco l’origine dell’etica della responsabilità, cioè, in ultima analisi, della necessità, a volte, di scendere a compromessi con i nostri principi.
Ad esempio la franchezza (o trasparenza) è certamente un principio importante, ma lo è anche la cortesia. La mediazione tra i due principi potrebbe indurci a forme di “ipocrisia” più o meno apparente. D’altra parte una cosa è mentire all’altro perché stiamo “macchinando” trame ai suoi danni e a nostro vantaggio, altra cosa farlo per gentilezza, per non offenderlo o ferirlo. Per tacere delle circostanze nelle quali è diverso il codice di emittente e ricevente: per me “Ci vediamo”, ad esempio, potrebbe essere un modo di dire, equivalente ad “arrivederci”, e non implicare un effettivo impegno a rivederti; per te potrebbe implicare proprio un impegno di questo tipo, il che fa sì che io ti deluda.
Spesso, tuttavia, la distinzione tra ipocrisia “buona” e “cattiva” è sottile. Tra coniugi il rischio è, a volte, che per un malinteso senso della “delicatezza” si finiscano per nascondere troppe cose, col risultato che ci si allontana sempre più l’uno dall’altro, anche senza volerlo.
Più spesso, però, l’ipocrisia è studiata, si recita una parte (hypokritès in greco significa “attore”) per conseguire ben determinati scopi, come un tradimento. Torniamo, così, al tema di oggi.
“Attore” (“hypokritès“) in questo senso, e dei migliori, nutrito dell’arte “sofistica” di tessere trame, giustificandosi a posteriori, fu Giasone, come viene rappresentato nella Medea di Euripide. Come molti “mariti” dei nostri giorni (e anche molte “mogli”!), Giasone arriva perfino a sostenere di avere agito come ha agito per il bene del coniuge: l’avrebbe abbandonata per sposare la figlia del re di Corinto Creonte (l’accusatore di Antigone, nell’omonima tragedia di Sofocle, che abbiamo già incontrato), per conseguire un importante ruolo politico , che gli avrebbe promesso di garantire a Medea (e ai figli avuti da lei) sicurezza economica e protezione. Lamenta che le donne, condizionate dalle loro “passioni” (e qui emerge tutta la misogina dei Greci), avrebbero troppo a cuore il “talamo”, cioè il letto nuziale e i correlati rapporti sessuali. Accusa Medea di essere ingrata: in ultima analisi l’ha emancipata dal popolo barbaro da cui proviene e le ha “offerto” la superiore civiltà dell’Ellade (e qui emerge il tipico nazionalismo ellenico).
Ecco, per chi vuole rileggerselo (in un italiano un po’ aulico e arcaico), il discorso di Giasone.
Medea, dal canto suo, appare legittimamente “arrabbiata”, furibonda, per il torto subito (a riprova della “ragionevolezza” delle nostre passioni), anche se da alcuni suoi gesti si tradisce il troppo amore rovesciatosi poi in odio: per amore di Giasone avrebbe tradito il padre, ucciso il fratello, abbandonata la patria (la Colchide), trafugato il vello d’oro, sarebbe fuggita con gli Argonauti ecc.
Al di là delle differenze storiche e culturali tra noi e gli antichi Greci (ruoli ben distinti di uomo e donna, l’uno dedito alla vita politica, l’altra “assegnata” al governo della casa; pregiudizio favorevole ai Greci nei confronti degli altri popoli, giudicati barbari ecc.) il contrasto tra Giasone e Medea ricorda da vicino molti conflitti coniugali anche moderni. L’altro, nel rapporto coniugale, potrebbe rivelarsi diverso da come appariva quando ci si era innamorati di lui (il timore espresso da Lucio Battisti in Con il nastro rosa). Anche l’esito tragico del conflitto tra Giasone e Medea (di cui parleremo la prossima volta) ricorda eventi purtroppo ben noti alle cronache. Del resto non sarebbe difficile stilare un elenco di efferati delitti, riportati dall’odierna cronaca nera, ed associare a ciascuno di essi una tragedia greca classica (episodi di uxoricidio, matricidio, parricidio, pedofilia, incesto ecc.).
E noi, nei panni di Medea, avendo un solo giorno a disposizione, quello concessogli da Creonte, prima di dover andare in esilio con i figli avuti da Giasone, che faremmo? Ce ne staremmo zitti per evitare altri problemi? Sparleremmo di Giasone tutto il tempo per vendicarci “verbalmente” di lui? O faremmo di peggio?…
Incontro del 9 agosto 2016
La saggezza consiglierebbe a Medea di accettare la proposta di Creonte: andarsene con “gli alimenti” passati da Giasone per l’interesse suo e dei figli avuti dal marito. Si tratterebbe del “male minore” nelle circostanze date, dunque del bene maggiore. Se ha ragione Socrate e ciascuno non fa altro che quello che crede sia meglio, Medea, che sa perfettamente che sarebbe meglio per lei e per tutti accettare la proposta di Creonte, dovrebbe comportarsi di conseguenza. Ma Euripide, l’autore del dramma, forse in polemica proprio con Socrate, mette in bocca a Medea una frase (successivamente resa da Ovidio con l’espressione: “Vedo e approvo le cose migliori, ma faccio le peggiori”) che suggerisce come, a volte, si possa fare il male pur sapendo che è tale.
Leggiamo tale frase a conclusione del lungo monologo (qui riportato integralmente) in cui Medea, visibilmente preda di un conflitto tra desideri, mostra, da un lato, tutto il suo amore per i figli (amore che la fa quasi esitare e sembra distoglierla, a tratti, dal suo turpe disegno, quello di ucciderli per vendicarsi del marito), dall’altro lato la tragica consapevolezza di un destino a cui non si vuole sottrarre:
Intendo ben che scempio son per compiere; ma piú che il senno può la passione, che di gran mali pei mortali è causa.
Insomma, Medea non riesce a resistere al desiderio di vendicarsi del marito – sia per il torto che le ha fatto, sia, ancor di più, forse, per la “brutta figura” che le ha fatto fare pubblicamente (i Greci , come sappiamo, cercavano in tutti modi di evitare la vergogna, quasi più che il senso di colpa) – e progetta di uccidere i suoi stessi figli, avuti da lui, per ferirlo atrocemente.
Quante volte, ancor oggi, nei dissidi tra moglie e marito, ci vanno di mezzo i figli, che diventano strumenti nelle mani dell’una o dell’altro per colpire il proprio partner? A volte le madri giungono perfino, come ben noti casi di cronaca giudiziaria documentano, ad uccidere i propri figli, a causa (più che di un difficile rapporto col marito, come nel caso di Medea) di un rapporto irrisolto con loro.
L’ipotesi è che ciascuno di noi sia “un po’ Medea”. Oppure no? Certo, l’educazione ci distoglie dal dare corso ai nostri piccoli desideri di vendetta, ai nostri piccoli rancori… Ma siamo proprio certi di non averne? E, spesso, proprio nei confronti di chi più amiamo?
Quante volte, arrabbiati con una persona cara che vediamo magari autodistruggersi (col fumo, con l’alcool ecc.), esclameremmo: “Quando fai così, ti ammazzerei…”. “Grazie”, potrebbe rispondere questa persona, “così mi togli dall’impiccio di farlo proprio col fumo, con l’alcool ecc.”. Spesso odiamo chi amiamo, per troppo amore.
Come nei casi dei cosiddetti “femminicidi”. La “vulgata” suggerisce di dire: “L’uomo che uccide la sua donna non l’amava veramente, non fu vero amore”. Facile escamotage. O si tratta proprio di amore, di un eccesso di amore, di un amore malato?
Domandiamocelo. Se siamo innamorati, saremmo davvero disposti, per amore del bene dell’altro, a rinunciare all’altro, se l’altro si innamora di una terza persona? Una persona innamorata non è anche gelosa? Allora, forse, in ogni forma di amore si mescola un lato egoistico e un lato altruistico. Semplicemente: quando prevale l’egoismo, senza più limiti, si può finire per uccidere chi si ama per sottrarlo ad ogni altro e portarselo magari con sé nella tomba (come avveniva in Egitto antico e nell’India precoloniale, allorché, alla morte del marito, anche la morte veniva sacrificata per consentirle di seguirlo nel regno dei morti).
Come Medea, molti di noi, a volte, vivono conflitti e non sembrano fare quello che credono bene. Ammettiamo, in questi casi, di agire per impulso. Non uccideremmo? Ne siamo sicuri? Se siamo abitati da un'”anima irascibile”, come la chiamerebbe Platone, incline alla vendetta, la cosa migliore è ignorarla, obbedendo semplicemente ai dettami della ragione? Che potremmo farle per “darle un contentino”?
Secondo il filosofo Nietzsche, ad esempio, il “superuomo”, davvero libero da condizionamenti, non prova risentimento, rancore, dunque non desidera vendicarsi. Ma chi, invece, desidera vendetta, è meglio che si vendichi, piuttosto che trattenersi, col rischio di “ammalarsi” (“incuttumarsi”, come si direbbe in siciliano). Ma è proprio questa la soluzione?
- Si potrebbe, quando qualcuno, ad esempio, ci umilia (come Giasone fece con Medea), cercare di migliorarsi: questo è un bene per noi, in assoluto; ma ci consente di prenderci anche una certa soddisfazione sull’altro.
- Oppure si potrebbe fare dell’ironia sul conto di chi ci ferisce: anche in questo modo, un po’ crudele, evitiamo di “metterci al suo stesso livello”.
- Oppure possiamo semplicemente allontanarci dall’altro: non ergerci sopra di lui, ma, orizzontalmente, creare dello spazio tra noi e lui, per proteggerci, senza stare al suo gioco.
In fondo i grandi maestri antichi, in modo diverso, ci suggeriscono proprio questo, di non metterci al livello di chi ci offende: sia che, come nel caso degli stoici, ci suggeriscano di ignorarlo o di comprenderlo; sia che, come nel caso di Gesù, ci invitino addirittura a “porgere l’altra guancia” (Mt, 5, 39).
Questa celebre esortazione che significa? Non è certo un’esortazione alla debolezza, a subire senza reagire, magari per paura delle conseguenze. Al contrario: è un invito a non stare al gioco dell’altro. In questo preciso senso Gandhi predicava la non-violenza (ahimsa), come atto di forza e di coraggio. Ecco perché sosteneva, in modo provocatorio: “C’è speranza per i violenti, perché potrebbero scegliere di non esserlo, se ne hanno la forza; non c’è speranza per i deboli”.
L’altro che ci offende può non essere soltanto un singolo, ma un’intera “cultura”. Possiamo dire di venire offesi dall’Islam, ad esempio? Certamente no, ma dal fondamentalismo islamico sicuramente sì, come lo saremmo dal fondamentalismo cristiano.
In generale chi ci si vuole imporre ci disturba (siano singoli o gruppi umani). Come dovremmo interagire con costoro? Dovremmo educarli ai nostri valori? Ma quali sono i nostri valori? Se, per reazione, volessimo imporre p.e. ai fondamentalisti islamici una forma di “integralismo cattolico” non faremmo, in fondo, il loro gioco? Non scenderemmo al loro livello?
In ultima analisi “noi” (intesi come occidentali) siamo eredi del cristianesimo, certo, ma anche dell’illuminismo (della Rivoluzione Francese). Il problema è che i “valori” che abbiamo ereditato dall’illuminismo (libertà, democrazia, pluralismo ecc.) ci difendono solo molto “debolmente” da coloro che li avversano (perché mentre noi concediamo loro diritto di parola e propaganda, non avviene il contrario).
Dobbiamo per questo abdicare alla nostra libertà in nome della sicurezza? Dobbiamo imporre agli altri i nostri valori per non farci invadere dai loro? O dobbiamo tentare sempre ostinatamente la via del dialogo (quella che, ad esempio, non perseguì Medea….) per “demolire” gli opposti dogmatismi?
Forse dovremmo educare i “credenti” di tutte le religioni a riflettere su quello che credono, a non prendere alla lettera insegnamenti impartiti migliaia di anni fa (per esempio quello che prescrive di lapidare le donne adultere), ma a interpretarli simbolicamente, alla luce della ragione e dell’esperienza storica (come molti cristiani, ma anche molti musulmani, colti, hanno imparato a fare). Forse solo la filosofia ci può salvare….
Ma non sarà troppo tardi? Hitler, nel Mein Kampf, insegna che le masse sono sensibili ai dogmi e alle semplificazioni, tutto il contrario di ciò che può procurare un… pensiero davvero creativo.
Non saremmo, magari, come molti credono, simili ai Romani nella fase della decadenza del loro impero, invasi dai barbari, certo, ma difesi da altrettanti barbari che, ormai, andavano occupando tutti i posti chiave dell’amministrazione e della politica (barbari non solo dal punto di vista etnico, ma anche e soprattutto per la loro ignoranza)?
Incontro del 16 agosto 2016
Riconsideriamo le questioni che hanno ispirato tutto il nostro percorso: “Chi sono veramente gli altri?”, “Come li possiamo considerare?”, “Che rapporti dobbiamo stabilire con loro?”,”Come ce ne possiamo ‘difendere’?”.
Concentriamoci, ad esempio, sulle relazioni d’amore. Come evitare che si sciolgano rovinosamente, producendo danni (come nel caso di Giasone & Medea, di Amleto & Ofelia, di “Lui” & “Lei” nella canzone Con il nastro rosa di Battisti Mogol…)?
Bisogna certamente coltivare la relazione. Ma come? Qualsiasi gesto compiuto al solo scopo di “salvare la relazione” (prodigarsi in doni costosi, garantire la propria presenza in casa, aiutare il proprio partner nelle faccende domestiche o, peggio ancora, scambiare con lui o con lei affettuosità “affettate” o “ipocrite”) rischia di essere e apparire “strumentale”, squallido. Piuttosto. tutti questi gesti e, soprattutto, il dialogo sincero tra partner possono sortire l’effetto di “salvare la relazione” tanto più quanto meno tale effetto è perseguito coscientemente come scopo (secondo una logica che in filosofia si denomina “eterogènesi dei fini“: quell’azione che per me ha un determinato fine, si rivela un mezzo perché qualcuno o qualcos’altro consegue un “secondo” fine, che io ignoravo).
Ma, quando si dona qualcosa, che cosa permette di escludere che non lo si faccia “utilitaristicamente”? Forse il fatto che il dono non è misurato”, calcolato (quando ad es. non corrisponde esattamente a quanto chi dona ha a suo tempo ricevuto o non è un dono in denaro [ammissibile solo rivolto a persone molto amiche che ce lo chiedano] ecc.).
Anche nei rapporti di semplice amicizia vige la “legge del caffè”: se un collega è solito offrire caffè a un altro collega, questo gesto può essere considerato bello e spontaneo (origine di una possibile amicizia) se e quando lo stesso collega che offre è solito ricevere volentieri dall’altro analoghe offerte, ma in modo tale da non raggiungere (se non casualmente) la perfetta equivalenza tra i caffé offerti dall’uno o dall’altro. Se questa equivalenza fosse, infatti, ricercata, ci sarebbe da sospettare che dietro ciascun gesto, apparentemente spontaneo, si nasconda una transazione economica (gioco a somma zero), per cui, di fatto, ciascuno finisce per pagare solo i caffè che beve. L’obiettivo sarebbe quello di “sdebitarsi” completamente con il collega in modo tale da non dovergli alcunché, né da restare in credito nei suoi confronti. Nessun legame sarebbe stabilito.
L’esempio del caffè (che può essere esteso ai doni che gli amici si scambiano reciprocamente) mostra un’analogia tra i rapporti governati da èros (come quelli amorosi) e quelli governati dalla philìa (come quelli amicali): in entrambi i casi, se il rapporto è autentico, non si basa sull’utilità (forme di amicizie di infimo grado per Aristotele), ma sul bene dell’altro (in cui, secondo Aristotele, chi ama vede un altro se stesso) o, almeno, sul piacere comune.
Si distinguono, infatti, rapporti basati prevalentemente sull’affetto (spesso sono tali le amicizie che risalgono all’infanzia), tra persone che, magari, condividono ormai poco o nulla della vita p.e. professionale, ma che sarebbero pronti a dare la vita l’una per l’altra, e rapporti basati sulla condivisione di interessi, tra persone che, magari, sono colleghi di lavoro o di gioco, ma che, in caso di necessità, sono molto meno disponibili ad aiutarci degli amici “affettivi”.
Non parliamo qui dei rapporti fondati su agàpe o caritas (l’amore in senso cristiano) nei quali chi dona è pago del dono e non si attende alcunché da chi riceve. Nelle forme di amore e di amicizia “normali”, come insegna ancora Aristotele, anche quando sono rivolte al bene dell’altro (e colui che dà è, pertanto, felice di dare), è opportuno che anche chi riceve talvolta ricambi (anche se, come detto, non in misura di stabilire un’esatta equivalenza tra chi riceve e chi dà), affinché non sorga il sospetto che sia chi riceve ad approfittare di chi dà, utilitaristicamente.
Ma perché cercare di “verificare” una cosa così profonda come l’amore o l’amicizia facendo la “contabilità” del dare e del ricevere? Non si rischia di ridurre un sentimento a qualcosa di “materiale”?
Eppure, se, come i positivisti logici, filosofi dei primi del Novecento, considerassimo che “esiste” solo ciò che può essere “sperimentato”, allora l’amore non esisterebbe se non si traducesse in forme “materiali”. Ma questa visione appare squallida: mia moglie mi amerebbe solo se mi garantisse una certa “quantità” di presenza, di doni, di servizi ecc. misurabile e verificabile!
D’altra parte anche l’opposto sarebbe ridicolo. Immaginiamo che mia moglie mi dicesse: “Ti amo di tutto cuore, ma ti tradisco, non mi curo di te, ho aperto un conto in Svizzera in cui ho trasferito i nostri soldi ecc.” sicuramente il suo “sentimento” sarebbe sospetto.
Possiamo forse concordare su quanto segue: i gesti d’amore (o di amicizia) sono necessari perché si possa credere che vi sia amore (o amicizia), ma non sufficienti, in effetti, a dimostrare che il sentimento sia autentico perché può sempre sorgere il sospetto che tali gesti siano “strumentali”.
Ma quali gesti sono soprattutto “fecondi”, ossia possono consolidare una relazione d’amore o di amicizia pur senza “mirare” strumentalmente a tale fine? Forse i gesti che consolidano l’amore dell’anima dell’altro, più che del corpo (destinato a sfiorire). Come suggerisce Platone, nel Simposio, se mi piace il corpo dell’altro, destinato a sfiorire, anche il mio rapporto con lui tramonterà; ma se amo la sua anima, che può crescere in saggezza col crescere dell’età, il rapporto potrà rafforzarsi.
Ma quando i doni reciproci, l’attenzione, la cura ecc. sono sinceri e non strumentali, tutto questo garantisce forse che l’amore sopravviva? Si direbbe di no, per quella irriducibile libertà umana che fece esclamare a Sofocle “Straordinario è l’uomo!”, alla quale non vorremmo magicamente rinunciare (anche se rinunciarvi ci garantirebbe maggiore sicurezza), ma che ci espone a tutti i rischi del caso nell’incontro con l’altro, più o meno conosciuto (come nelle relazioni d’amore o di amicizia), o del tutto sconosciuto.
Ecco, forse, perché Platone sostiene che al di sopra dell’amore per gli altri (anche per le loro anime) c’è l’amore per le leggi (lo Stato), per la scienza, per Dio…
Certo, il rischio è quello che tutto questo amore per la scienza finisca per renderci insensibili a nostra moglie, come sembra sia accaduto ad esempio ad Einstein; analogamente, un amore sviscerato per l’arte ci può portare a trascurare i lati oscuri, dal punto di vista morale, di tanti artisti famosi. Ma, appunto, l’uomo è un mistero: può diventare un angelo, un demonio o, forse, entrambe le cose, in campi diversi, simultaneamente.
Incontro del 23 agosto
Finora ci siamo interrogati sugli altri, in quanto possono tradirci, deluderci, sorprenderci, farci violenza ecc. Ma, all’inizio di questo percorso, ci eravamo chiesti che cosa fare, qualora fossimo noi a evolvere, a crescere, a trasformarci, magari tradendo, deludendo o sorprendendo, a nostra volta, le persone che ci sono care.
In effetti non è così facile stabilire, ad esempio all’interno di una coppia, a meno che non vi sia un osservatore esterno alla coppia, se, tra due coniugi, uno sia progredito”, mentre l’altro è rimasto fermo, o, piuttosto, il primo sia semplicemente rimasto fermo, mentre il secondo è regredito”.
Ciò dipende da una certa “relatività del moto”, applicabile anche a questo genere di situazioni (come si applica, ad esempio, a due corpi nello spazio, cfr. il caso dei due treni in movimento rettilineo uniforme che si incrociano: il passeggero di uno de due treni non è in grado, solo guardando al moto dell’altro treno, di stabilire quale dei due treni sia in movimento e quale in quiete).
Non è neanche del tutto possibile stabilire, quando due destini tendono a divaricarsi, chi evolva e chi no. Forse vengono semplicemente intraprese strade diverse, entrambe legittime e degne di considerazione.
Che fare, comunque, quando, nostro malgrado, ci sembra di “evolvere” più di coloro che amiamo o comunque in una direzione diversa dalla loro?
Potremmo cercare di metterli in guardia, parlando loro di quello che ora ci appassiona. Forse faremmo anche bene a scrivere a noi stessi che cosa ci riproponiamo da noi stessi (magari ogni primo dell’anno), per ricordare a noi stessi di non essere “trascinati” nella routines dagli altri.
Ma tutto questo è davvero sufficiente? Gli altri, spesso, ci “frenano”, non solo con espliciti comportamenti “ostili” nei nostri confronti o nei confronti delle nuove esperienze che ci appassionano, ma, molto più spesso, inconsciamente, suscitando in noi sensi di colpa o semplicemente giocando sulla nostra “pigrizia” (sul desiderio di un “quieto vivere”, sull’inclinazione a non “sollevare questioni”). Ma a che prezzo?
Si potrebbe anche cercare di interessare coloro che amiamo delle cose che ci appassionano, per coinvolgerli. Ma la cosa non sempre riesce. Si può giungere ad accordi su singoli punti. Non è possibile, però, forse, condividere proprio tutto e, su certe cose, ci si può concedere un po’ di indipendenza. Ma fino a quale limite?
Un esempio classico è dato dalla fruizione di programmi televisivi. Due coniugi posso accordarsi
- di vedere sempre gli stessi programmi (decidendo come? a turno? oppure lasciando la decisione sempre a “chi comanda” nella coppia?);
- oppure in modo tale che ciascuno sia libero di seguire sempre il programma che più gli piace (a rischio di vedere sempre programmi diversi in stanze diverse su televisori diversi);
- o, infine, scegliendo una via di mezzo tra questi due estremi: sforzarsi, spesso, per amore dell’altro, di condividere la fruizione degli stessi programmi (anche quando ce ne piacerebbe un altro); ma non sempre, qualora vi fosse davvero qualcosa che ci sta a cuore e che l’altro non ha alcuna intenzione di vedere.
In generale, condividere non significa solo “subire” i gusti dell’altro per “equità” (avendo magari, a nostra volta, imposto a lui o a lei i nostri gusti in altre occasioni), ma sforzarsi di comprendere ciò che piace all’altro, più che a noi, cercando di metterci nei suoi panni.
In questo modo la condivisione di “attività” diventa un’occasione di approfondimento della reciproca conoscenza.
Guardando un programma televisivo che piace a mia moglie (e che magari io non avrei scelto) non imparo solo cose nuove dal programma medesimo (supponiamo un documentario naturalistico), ma imparo cose nuove anche sul conto di mia moglie che per quel determinato programma ha optato.
Tutti questi “problemi” si moltiplicano quando l’altro, con cui vorrei condividere esperienze, non è un mio pari (una moglie, un amico, un conoscente, un collega ecc.), ma qualcuno che dipende da me e che io devo educare (un figlio, uno studente ecc.). In questi casi le divergenze sono meno tollerabili perché sentiamo di avere un compito educativo nei confronti dell’altra persona: eventuali sue scelte difformi da quello che desideriamo che egli scelga ci potrebbero inquietare.
Ma un figlio cresce. Fino a una certa sua età, ad esempio, se noi ci siamo convertiti, ad esempio, a una certa religione, è ragionevole che cerchiamo di “imporgliela”. L’alternativa non consisterebbe, infatti, nel lasciarlo “libero” di scegliere la religione che vuole (o anche nessuna religione), ma nell’abbandonarlo alle “imposizioni”, talora subdole, di amici, insegnanti, media ecc. Oltre una certa sua età, tuttavia, insistere a condurre un ragazzo “a messa” o imporgli p.e. di cresimarsi sarebbe sbagliato e controproducente.
Fin da piccoli, come testimonia l’esperienza, nasciamo con caratteri e inclinazioni innate differenti. Questi non possono essere soffocati, soltanto, al limite, orientati.
In ultima analisi quale obiettivo migliore può darsi un genitore o un insegnante di quello che consiste nel cercare di aiutare il proprio figlio o il proprio alunno ad essere felice?
Le scelte che costui tenderà a fare possono, certo, venire corrette o, magari, impedite, finché egli è sotto la nostra tutela, per il suo bene, ossia quando è ragionevole supporre che lo renderanno infelice (cioè che egli stesso se ne pentirà).
Ma, nella misura del possibile, non dovremmo desiderare che lui desideri per sé quello che noi desidereremmo per lui (di diventare magari quello che a noi sarebbe piaciuto diventare, ma non siamo riusciti a diventare), a meno che quello che desideriamo per lui non sia appunto, semplicemente, la felicità.
ARRIVEDERCI AL PROSSIMO CORSO






