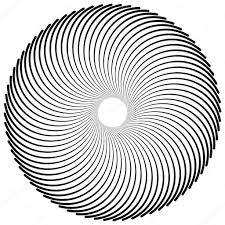
Che cosa sappiamo di noi stessi e del mondo?
Ciò che “sappiamo” (ciò di cui abbiamo “scienza”) riguarda il modo in cui “le cose” ci appaiono (N. B. il fatto stesso che appaiano “cose”, l’una distinta dall’altra, è qualcosa che ci appare). “Sappiamo”, ad esempio, che i corpi pesanti cadono con una certa accelerazione al livello del mare. “Sappiamo” che ci siamo evoluti, in quanto homo sapiens, da primati antropomorfi in milioni di anni. “Sappiamo” che l’universo osservabile è nato probabilmente poco più di 13 miliardi di anni fa e che il suo diametro è di circa 80 miliardi di anni luce etc.
Di tutte queste “cose” abbiamo “scienza”. Il che significa semplicemente: esistono modelli esplicativi collaudati di questi fenomeni. Tutto questo “sapere” deriva, infatti, da modelli teorici compatibili con i fenomeni osservabili, soggetti a potenziale falsificazione e assunti come veri (“saputi”) fino a prova contraria.
Tuttavia, tali modelli si riferiscono appunto soltanto al modo in cui “le cose” ci appaiono, ai fenomeni. Ora, in questo apparire non è affatto facile, in prima istanza, distinguere tra
- la componente che dipende da ciò che “esiste” indipendentemente da “noi” e
- la componente che dipende dal modo in cui “noi” percepiamo (con i sensi) e comprendiamo (con – quello che appare come – il nostro cervello) il mondo.
Ad esempio, siamo abbastanza certi che colori, suoni, odori etc., le cosiddette “qualità secondarie” o “soggettive”, siano percepiti come tali per effetto del modo di funzionare dei nostri sensi. “Là fuori” c’è senz’altro “qualcosa”, ad esempio ci potrebbe essere una radiazione elettromagnetica di una certa lunghezza d’onda, onde elastiche di una certa ampiezza, molecole volatili di una certa sostanza etc. Ma tutte queste “cose” ci appaiono come colori, suoni, odori etc. perché abbiamo determinati organi di senso e (quello che appare come) un determinato cervello. Un altro vivente potrebbe percepire queste “cose” in modo piuttosto diverso (certi animali percepiscono per esempio i c.d. “ultrasuoni”, altri vedono probabilmente in modo “monocromatico” ciò che percepiamo colorato etc.).
Ora, le stesse qualità c.d. “primarie” od “oggettive”, per esempio le grandezze fisiche dipendenti da spazio e tempo (volume, velocità, massa etc.), potrebbero a loro volta dipendere dal nostro modo di percepire e comprendere le cose, cioè dai nostri sensi e dal nostro “cervello” (“cervello” tra virgolette, perché si tratta semplicemente del modo in cui appare – non necessariamente di ciò che “è” – l’”organo” che ci permette di comprendere).
Vi sono, anzi, precisi indizi che spazio e tempo non siano “reali”, ossia indipendenti da noi, ma siano piuttosto modi in cui le cose ci appaiono. In altre parole: senza di noi spazio e tempo potrebbero non esistere come tali.
Come spiega il fisico Carlo Rovelli, ad esempio, la variabile “tempo” non è affatto necessaria per comprendere i fenomeni quantistici e non appare, infatti, nelle relative equazioni. Lo stesso spazio, nel quale vengono collocati gli stessi “oggetti” quantistici, è il cosiddetto “spazio di Hilbert”, uno spazio multidimensionale, costruito ad hoc per rendere ragione dei relativi fenomeni, dal tutto diverso dallo spazio di cui facciamo esperienza a livello macroscopico.
Come è noto, nella teoria della relatività di Einstein il tempo è assimilabile a una dimensione spaziale. Secondo questa teoria, in particolare, esso si dilata o si contrae in riferimento a un determinato oggetto a seconda del moto dell’osservatore rispetto a tale oggetto. E questo vale anche dello spazio. Tutto sembra suggerire che spazio e tempo siano tali solo in relazione a un punto di vista o alla prospettiva di un “osservatore”.
Potremmo bensì essere tentati di isolare (con sir Arthur Eddington) una “freccia del tempo” in qualche modo oggettiva, in riferimento a quei processi che fanno registrare un incremento dell’entropia, ossia della misura del disordine ad essi associato. Tuttavia, questa stessa misura dipende dai criteri di misurazione del disordine adottati da un osservatore.
Ciò appare ancora più chiaro se ricorriamo alla nozione di “informazione”. Se intendiamo l’aumento dell’entropia/disordine come un incremento dell’incertezza dovuto a un incremento della quantità di informazione in gioco, appare chiaro che questa incertezza è tale solo in rapporto alle esigenze di comprensione/decodificazione di un “interprete/osservatore”.
Tutto questo risulta ancora più chiaro se rovesciamo la prospettiva e ci chiediamo: “Che cosa ‘resta’ del mondo se facciamo astrazione di noi stessi in quanto osservatori?”. Non colori, suoni, odori; non, probabilmente, spazio, tempo, dunque volumi, velocità, masse etc.
Resta una “cosa in sé”, fuori dello spazio e del tempo. Essa appare nel modo in cui appare (come variopinta, spazializzata e temporalizzata), ossia come fenomeno la cui evoluzione è coerente e congruente con i modelli messi in campo dalla “scienza” per interpretarlo, solo in quanto vi è un osservatore a cui essa appare in questo modo.
Se, infatti, la cosa in sé è in se stessa fuori da spazio e tempo, c’è da supporre che il “mondo” come appare (e come la “scienza” lo interpreta) derivi dall’interazione tra l’osservatore e questa stessa cosa in sé.
Possiamo congetturare alcune proprietà di questa cosa in sé. Essa è “una” e “una sola” nella misura in cui non si articola nello spazio e nel tempo (se essi sono tali soltanto per noi). Tuttavia, ciò non esclude che essa sia “rigata”, per così dire (come la lastra di un ologramma). Essa potrebbe essere, infatti, caratterizzata da righe di codice che permettono a un osservatore di farla apparire come articolata e frammentata nello spazio e nel tempo.
Peraltro è un dato perfino banale che i 13 miliardi di anni che ci separano dal big bang e i 80 miliardi di anni luce che sembrano costituire il diametro del nostro universo sono tali soltanto per noi, in quanto osservatori. Si può forse assegnare un’età all’universo e una misura al suo diametro (misura connessa con l’età, dal momento che il nostro universo appare espandersi) senza riferimento a un determinato istante/punto di vista assunto come “presente”? Ma il “presente” si distingue dal passato e dal futuro perché è tale per “noi”, qui e ora.
Facciamo un passo in più. Noi stessi, non in quanto appariamo a noi stessi come appariamo, ossia come viventi con un certo corpo dotato di sistema nervoso centrale, ma in quanto “siamo” qualcosa, siamo, cioè, parte di ciò che esiste, indipendentemente dall’essere o meno osservato, apparteniamo a questa “cosa in sé” (a ciò che veramente è, non a ciò che appare), a ciò che ricorrendo al linguaggio di Kant possiamo chiamare il noumeno, per distinguerlo dai fenomeni.
Se questo è vero, possiamo azzardare che l’universo osservabile non è che un modo in cui la cosa in sé (il noumeno) appare a se stessa o, il che è lo stesso, il tutto (che è) appare a se stesso. In questo quadro ciascuno di noi o, per essere più precisi, ciascun momento nel quale sono dati un osservatore e un osservato, non è che un diverso modo in cui il tutto appare a se stesso.
In questo contesto si può chiarire anche il significato di ciò che denominiamo “coscienza”. Non si tratta, sotto questo profilo, soltanto della funzione biologica di un organismo vivente, ma si tratta anche e soprattutto del modo in cui l’universo appare a se stesso. Ciò che constatiamo è che tale apparire si registra in presenza di un vivente che offre, per così dire, all’universo il punto di vista o la prospettiva da cui osservare se stesso. Ciascuno dei momenti in cui sono dati un osservatore e un osservato può essere dunque sinonimicamente denominato “occorrenza della coscienza”.
Se la “coscienza” è, dunque, il modo in cui l’universo (la cosa in sé) appare a se stesso attraverso di “noi”, attraverso quello che appare come il nostro corpo, il nostro corpo (dotato di sistema nervoso centrale) è, a sua volta, il modo cui noi appariamo a noi stessi.
Dopo la morte del corpo, attraverso cui per un certo tempo l’universo ha osservato se stesso, l’universo, presumibilmente, non potrà più apparire a se stesso in quella determinata prospettiva.
Sorge a questo punto la domanda esistenziale fondamentale. Può l’universo perdere del tutto coscienza di sé attraverso questo o quel corpo vivente? Può, cioè, non apparire più a se stesso?
Una risposta positiva a tale domanda presupporrebbe che ci potesse essere un tempo in cui l’universo non apparisse più a se stesso.
Ma, se il tempo è tale solo per noi, se esso implica, cioè, un osservatore, dunque una prospettiva, non ci può essere un tempo successivo a quello, presente, di cui si è coscienti, in cui l’universo non apparirà più a se stesso.
Ancora più assurdo sarebbe concepire un tempo antecedente a quello della nostra nascita in cui l’universo non fosse ancora cosciente di sé. Il transitare da questa immaginaria condizione inconscia a una condizione cosciente richiederebbe tempo. Ma il tempo già presuppone la coscienza! (Il fatto che non ci ricordiamo del modo in cui l’universo fosse prima che nascessimo non implica che non vi fossimo coscienti: vi sono infinite cose di cui non ci ricordiamo, ma che certamente abbiamo vissuto).
L’universo è, dunque, necessariamente eternamente cosciente di sé, in modi sempre diversi. In tale continua variazione o successione di occorrenze della coscienza consiste, appunto, lo scorrere del tempo.
Ciò che viene meno, quando muore un organismo vivente cosciente, è una certa prospettiva sul mondo. Del resto in ogni istante la prospettiva cambia. Quando mi sveglio il mondo appare diverso da com’era quando mi sono addormentato.
Tuttavia, se non può esistere alcun universo che non appaia continuamente a se stesso, ciò richiede che vi sia sempre “qualcuno” (un corpo vivente) attraverso cui l’universo appare, che ne sia, cioè, cosciente.
Ora, questo qualcuno devo sempre essere “io” affinché l’universo possa apparire a se stesso. Infatti, se la coscienza in gioco non fosse “mia” non sarebbe coscienza affatto.
La coscienza è tale sempre solo per me. La coscienza “attribuita” ad altri non è coscienza. Tale “coscienza” putativa non è qui e ora, non è presente, non permette all’universo di apparire a se stesso in questa determinata prospettiva.
Non basta, infatti, dire che “l’io” o “la coscienza” è il luogo in cui l’universo appare. Bisogna dire a rigore che io sono il luogo in cui l’universo appare. Nella prima formulazione si fa dell’io contraddittoriamente una “terza persona”, facendo riferimento a un apparire a cui, appunto, ci si limita a far riferimento ma che, di fatto, non appare. Un universo che apparisse a qualcuno che non fossi io non apparirebbe affatto perché non apparirebbe ora, ma apparirebbe – assurdamente – in un tempo diverso dal presente. Soltanto il presente, infatti, è il tempo della manifestazione.
Ricapitolando, che cosa sappiamo, dunque, di noi stessi e del mondo?
Le “cose” verosimilmente non sono come appaiono. Presumibilmente non sono neppure “cose”, al plurale (tale moltiplicazione è verosimilmente l’effetto, come in un gioco di specchi, della manifestazione spaziotemporale di ciò che esiste). Esiste verosimilmente una cosa sola, e questa appare a se stessa nella prospettiva offerta di volta in volta da (quelli che appaiono come) corpi dotati di sistema nervoso centrale, come è anche il mio attuale corpo vivente. Se questo è destinato a dissolversi, io stesso, invece, in quanto osservatore, coscienza che, di volta in volta, di corpo in corpo, l’universo ha di se stesso, sono destinato a permanere in eterno.
N.B. La persistenza della coscienza o dell’io non va intesa come persistenza del c.d. “sé” (self), di un’identità “personale”, consapevole di esistere come entità separata e memore del proprio passato. Anche senza abbandonare il proprio corpo, si può perdere completamente la memoria di “sé”, come nei casi di amnesia o nella malattia avanzata di Alzheimer. Ciò che esattamente mi accadrà dopo la “mia” morte, cioè, rectius, dopo la morte del mio corpo, è difficilmente congetturabile. Per un verso, infatti, non disporrò più di quell’insieme di organi che qui e ora sembrano funzionali, ad esempio, a ricordare e a ragionare (e che, quanto più sono danneggiati, tanto meno mi consentono di svolgere queste funzioni). Per altro verso potrebbe non essere più necessario disporre di organi per svolgere queste e altre funzioni, non essendovi più ostacoli, al di fuori del mondo sensibile, all’esercizio di queste funzioni stesse. Quello che è certo è che non è possibile finire nel nulla, il quale, per definizione, non è un luogo che ci possa accogliere o nel quale si possa andare.
Apparentemente finiamo nel nulla ogni volta che perdiamo coscienza, ad esempio quando ci addormentiamo. Tuttavia, le cose non stanno affatto così. Semplicemente, così come, durante la veglia, cambiamo via via prospettiva sul mondo, nell’addormentarci transitiamo attraverso diversi stati di coscienza: la veglia, il sogno, di nuovo la veglia. Il corpo attraverso cui osserviamo il mondo cade bensì a tratti nel cosiddetto “sonno profondo”, ma questa condizione è tale soltanto per un osservatore esterno a noi. Come in certe circostanze il tempo sembra “volare”, in altre sembra non passare mai, in altre ancora, come nel “sonno profondo”, esso viene semplicemente “saltato”. Tutto ciò non stupisce se ricordiamo che il tempo è relativo a un osservatore (Einstein), non è che la “misura del movimento” (Aristotele) e non esiste se non soggettivamente (Kant). In questa prospettiva la morte, comportando la dissoluzione del corpo attraverso cui siamo coscienti di questo mondo, non è che l’enigma che è sempre sembrata essere: un salto nell’ignoto.
antropologia, biologia, coscienza, cosmologia, epistemologia, fenomenologia, filosofia della mente, gnoselogia, neuroscienze, scienza dell'informazione, soteriologia, teologia
Alzheimer, amnesia, Aristotele, assoluto, cervello, coscienza, Eddington, Einstein, entropia, eterno, fenomeni, ignoto, immortalità, informazioni, io, ipotesi, ipotesi monista, Kant, meccanica quantistica, memoria, modelli, monismo, morte, noumeno, oggettivo, olografia, ologramma, osservatore, Parmenide, prospettiva, qualità primarie, qualità secondarie, quanti, relatività, Rovelli, sapere, scienza, sensi, soggettivo, sogni, sogno, sonno, sonno profondo, sopravvivenza, spazio, tempo, tutto, universo, universo osservabile, uno
